
Pearl Harbor: tutto o quasi è stato detto, ma ci sono alcune peculiarità degne di nota. Chi volesse anche solo informarsi sull’attacco giapponese alla base americana di Pearl Harbor del 7 dicembre 1941 troverebbe una formidabile quantità di materiale storico: tutto o quasi è stato detto sull’evento e, come sempre, vale la regola che la storia la raccontano i vincitori. Al di là della dinamica di un attacco pianificato minuziosamente e caratterizzato da una sofisticata manovra diversiva, vi sono alcune peculiarità degne di nota.
Il piano strategico generale giapponese era quello di avere mano libera nel sud est asiatico e, a questo fine, vi erano da tempo in corso trattative con gli Usa: il Presidente Roosevelt non era forse del tutto contrario a una qualche forma di accordo ma le condizioni americane erano ritenute inaccettabili. Era quindi necessario bloccare drasticamente gli americani prima che potessero interferire militarmente con questi piani. Fu quindi adottata quella che nel mondo dell’intelligence si chiama una politica della “doppia agenda”: le trattative con gli Usa erano proseguite ma, allo stesso tempo, veniva segretamente preparata una massiccia “spallata” militare nel caso del molto probabile fallimento del negoziato. Entrambi le parti forse si auguravano il fallimento dello stesso, anche se per motivi diversi.
Durante questa fase di preparazione i giapponesi, da sempre ossessionati dal concetto di perfezione anche nei dettagli più minimi, si ispirarono all’attacco inglese con aerosiluranti nel porto a Taranto: esso avvenne nella notte fra l’11 ed il 12 novembre del ’40 e fu un’operazione militare davvero da manuale. Una rete di spie tedesche attive negli Usa consentì ai giapponesi di perfezionare tutti gli elementi tecnici dell’attacco. A Taranto, come a Pearl Harbor, i fondali del porto non erano profondi e furono quindi necessarie delle modifiche al “governale” dei siluri che, simile nella funzione agli impennaggi di un aereo ma con la parte del timone in posizione fissa, consente di appruare o cabrare: la modifica dello stabilizzatore del governale consentiva al siluro di entrare in acqua evitando di appruare eccessivamente e quindi navigare quasi prossimo alla superficie.
 La rete di spie tedesche negli Usa che passava le informazioni ai giapponesi sull’ottimizzazione dei governali era diretta da un doppio agente al soldo dell’MI6 inglese di nome Dusan Popov, il quale già nel maggio del 1941 allertò i britannici: essi avvertirono l’intelligence Usa (Fbi) del fatto che i giapponesi stavano pianificando un massiccio attacco a un porto americano. Pearl Harbor era la sede della flotta del Pacifico, e quindi dei maggiori assetti operativi e logistici degli Usa in quell’area, e questo era l’unico bersaglio logico e plausibile. Nell’agosto del 1941, anche attraverso altre informazioni ricevute principalmente da Hoover (Fbi), gli Usa sapevano probabilmente con certezza ciò che Tokyo stava pianificando ma queste informazioni si fermarono per qualche motivo al più alto livello politico, ovvero il Presidente Roosevelt e il suo entourage.
La rete di spie tedesche negli Usa che passava le informazioni ai giapponesi sull’ottimizzazione dei governali era diretta da un doppio agente al soldo dell’MI6 inglese di nome Dusan Popov, il quale già nel maggio del 1941 allertò i britannici: essi avvertirono l’intelligence Usa (Fbi) del fatto che i giapponesi stavano pianificando un massiccio attacco a un porto americano. Pearl Harbor era la sede della flotta del Pacifico, e quindi dei maggiori assetti operativi e logistici degli Usa in quell’area, e questo era l’unico bersaglio logico e plausibile. Nell’agosto del 1941, anche attraverso altre informazioni ricevute principalmente da Hoover (Fbi), gli Usa sapevano probabilmente con certezza ciò che Tokyo stava pianificando ma queste informazioni si fermarono per qualche motivo al più alto livello politico, ovvero il Presidente Roosevelt e il suo entourage.
Comunque, le varie strutture di intelligence (la Cia ancora non esisteva) sottovalutarono grandemente le capacità militari dei giapponesi: viene il dubbio se tale sottovalutazione fosse dovuta solo a un’incredibile incapacità analitica oppure a intenzionali omissioni. La propensione degli Usa a creare notizie false o fabbricate al fine di alimentare tensioni ed eventualmente giustificare conflitti e ingerenze politiche a livello globale è ormai acclarata e un elemento storico.
Tornando a quello che successe prima e durante quel 7 di dicembre, il piano dell’Ammiraglio Yamamoto, grande architetto di quella che in codice fu chiamata “Operazione Z”, era quello di affondare buona parte della flotta americana nel Pacifico, soprattutto le due portaerei che si trovavano alla fonda, ovvero la Lexington e la Enterprise. La gemella Saratoga era in patria e altre portaerei e navi importanti erano nell’Atlantico, dove erano state trasferite in preparazione a un’entrata in guerra contro la Germania e l’Italia: ancora non c’era stata nessuna dichiarazione di guerra contro l’Asse ma i preparativi erano imponenti.
L’attacco a Pearl Harbor doveva essere portato mantenendo le portaerei molto lontane al fine di essere fuori dal raggio operativo della reazione controffensiva americana: questo avrebbe voluto dire anche fuori dall’autonomia operativa dei propri velivoli, che dopo l’attacco sarebbero stati sacrificati ammarando sulla via del rientro. Ma il piano che fu poi realmente attuato fu perfezionato da due ufficiali esperti in lotta aeronavale (Yamamoto non lo era), Takigiro Onishi e Minoru Genda, i quali pensarono invece di far avvicinare le portaerei di molto a Pearl Harbor affinché i velivoli coprissero una distanza relativamente breve fino agli obiettivi. Dopo il lancio dell’attacco le portaerei si sarebbero immediatamente allontanate alla massima velocità per raggiungere un punto di recupero molto lontano ma ancora nel raggio dei propri aerei. Il contrattacco americano avrebbe così dovuto essere portato a una distanza limite e forse fuori dal raggio d’azione dei propri velivoli. Geniale! Fondamentale era non farsi individuare durante l’avvicinamento fino al momento del lancio dalle portaerei: i radar dell’epoca erano comunque abbastanza primitivi e inefficaci a quelle distanze.
La flotta giapponese effettuò una magnifica manovra diversiva non puntando direttamente sulle Hawaii da Ovest ma dirigendosi verso le isole Curili, molto a Nord dell’obiettivo. Ciò richiese un rifornimento in navigazione che avvenne in rotta per le Curili, dove tutta la flotta si raggruppò: di questa flotta facevano parte almeno cinque sommergibili.
Dalle Curili venne lanciata l’ultima fase dell’attacco e la flotta giapponese fece prua verso le Hawaii provenendo da una direzione inaspettata. Ma verso le tre della mattina del 7 dicembre il cacciatorpediniere americano Ward affondò almeno uno dei sommergibili e iniziò uno scontro navale davanti al porto: avrebbe dovuto mettere in stato di massima allerta le forze Usa, nonostante formalmente non vi fosse uno stato di guerra contro il Giappone, ma inspiegabilmente questo non accadde.
Alle 6:00 decollò la prima ondata di aerei giapponesi: una stazione radar americana li individuò con discreto anticipo ma il responsabile dell’analisi delle immagini radar attribuì le tracce ad una formazione di B-17 il cui arrivo era previsto per la stessa ora. I primi 183 velivoli erano divisi in tre gruppi: il primo (siluranti e bombardieri) con obiettivi navali, il secondo e terzo con obiettivi terrestri principalmente aereoportuali (infrastrutture, velivoli a terra, postazioni di contraerea etc.). Al termine degli attacchi i danni inferti a terra furono devastanti, con ben oltre 300 velivoli fra distrutti e danneggiati, a fronte di una perdita di una trentina di aerei giapponesi.
Sui danni in rada alla flotta Usa ben poco c’è da dire: la flotta del Pacifico fu effettivamente decimata e resa di fatto inoperativa per lungo tempo. Ritenendo che le prime due ondate avessero efficacemente battuto gli obiettivi previsti, fu cancellata una terza ondata inizialmente pianificata che avrebbe dovuto concentrarsi su depositi e arsenali per azzerare completamente le capacità belliche Usa in tutto il Pacifico.
Il concetto di formazioni pesanti è stato concepito negli anni Trenta dalla nostra Regia Aeronautica e, durante la seconda guerra mondiale, si è evoluto nel concetto di package, ovvero formazioni costituite da stormi di velivoli con diverse capacità e armamenti. Pearl Harbor costituisce tuttora materia di studio nella dottrina militare aerea, tant’è che il concetto di package è ancora valido e in uso. Esso è stato largamente usato nella prima fase della Guerra del Golfo nel 1991, esclusivamente dedicata all’annientamento delle forze di terra irachene.
Ai “package” di cui si è fatto largo impiego hanno partecipato anche i nostri Tornado della Operazione Locusta. Il numero dei velivoli impiegati era intorno alle cento unità, includendo anche i numerosi assetti di supporto: i nostri Tornado si trovarono inseriti in sequenze di attacco pianificate con un margine di pochi secondi, senza quasi mai vedere gli altri componenti del package e mantenendo velocità indicate superiori ai 500 nodi (circa 900 Km/h) e quote intorno ai 20 mila piedi (circa 7000 metri). L’alto livello di coordinamento e di aggiornamento della situazione consentì anche in questo caso di preservare l’essenziale fattore sorpresa. Per mantenere questo fattore i giapponesi dell’operazione Z dovettero mantenere il gruppo navale compatto, trasferire le informazioni con segnali visivi e mantenere in volo un ferreo silenzio radio; ma ciò fu forse uno dei principali motivi per cui l’attacco ebbe risultati così devastanti, trovando gli americani impreparati, in una serena, tranquilla e rilassata mattinata di riposo domenicale.
Con il contributo di Antonio Urbano, ex Comandante del Gruppo dei caccia Tornado durante la guerra del Golfo
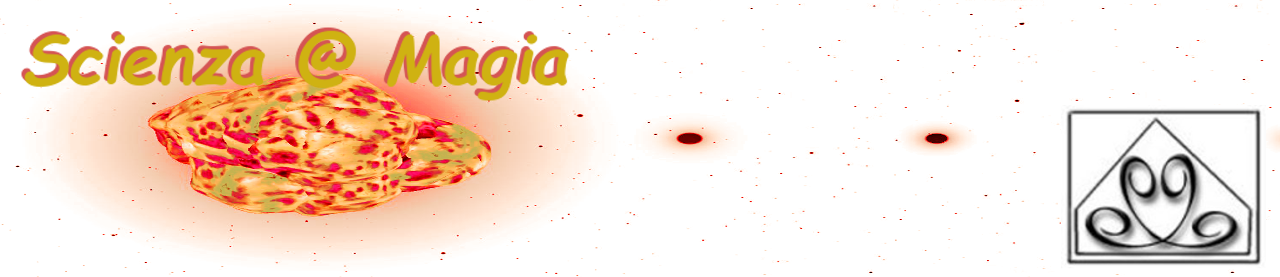
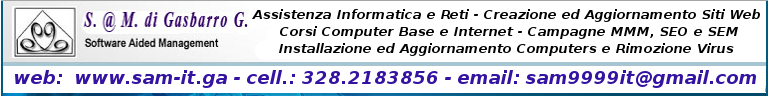


Lascia un commento