
Storia del disastro nucleare per antonomasia e della lotta che ne seguì, contro le sue conseguenze
1. Una città modello
La scena è la Polesia, una grande regione paludosa e poco popolata a nord di Kiev, con alcune delle foreste più estese d’Europa. Le acque scure del fiume Pryp’jat’, che la attraversa, si perdono in meandri e canali; dall’alto, la rete inestricabile dei corsi d’acqua assomiglia alle volute di fumo che si alzano da un incendio. Sulle rive del fiume, a una quindicina di chilometri di distanza dal confine con la Bielorussia, c’è l’antico insediamento di Černobyl’, che nell’aprile del 1986 ha meno di quindicimila abitanti. Esiste da mille anni, dicono i locali, e nei tre secoli precedenti è stato a maggioranza ebraica, anche se dopo la Rivoluzione d’Ottobre la comunità è diminuita molto.
Pochi chilometri più a nord, invece, una nuova città, sorta da più o meno quindici anni, è cresciuta fino a superare i quarantamila abitanti: Pryp’jat’, così chiamata dal fiume che le scorre accanto, alla cui periferia sudorientale sorge la centrale nucleare – la prima costruita in Ucraina. È una città modello, una delle poche in tutta l’Unione Sovietica in cui si possono trovare beni di lusso – e occidentali – come lo Chanel n.5. Un’azzeccata progettazione urbanistica e la natura circostante rendevano Pryp’jat’ un luogo a cui, negli anni successivi, gli abitanti sfollati avrebbero sempre pensato con nostalgia. I sovietici cominciarono la costruzione della centrale nei primi anni Settanta, sperando di farne la più grande d’Europa, ma all’inizio del 1986 solo quattro reattori degli otto programmati sono operativi, mentre il quinto è in costruzione e si prevede che venga acceso entro la fine dell’anno. Già così, la centrale di Černobyl’ produce da sola un settimo di tutta l’energia nucleare sovietica, cedendone buona parte ai paesi del blocco orientale, in particolare all’Ungheria.

Poco dopo l’una e mezza di notte di sabato 26 aprile 1986, dopo una calda e splendida giornata di primavera, gli abitanti di Pryp’jat’ si affacciarono sui balconi e videro, a pochi chilometri di distanza, il cielo terso sopra la centrale nucleare illuminato da un fascio di luce rosso acceso, brillante. «Non avevo mai visto niente di simile, neanche al cinema», descrisse la scena Nadezhda Petrovna Vygovskaya, che abitava al nono piano e aveva una «grande vista» sulla centrale. I vicini di casa di Nadezhda portarono in balcone i figli piccoli che non volevano saperne di addormentarsi, li presero in braccio e indicarono loro lo spettacolo, dicendo «Guarda!», mentre dal cielo cominciava a scendere una polvere nera. Nell’aria c’era uno strano odore, che pizzicava la gola e faceva lacrimare gli occhi. «Odore di centrale», lo chiamò qualcuno. Poi tutti rientrarono in casa, ma diversi non riuscirono a dormire, con il sospetto che alla centrale fosse successo qualcosa.
Più vicino al reattore, duecentosettanta persone lavoravano nel turno notturno alla costruzione del reattore numero 5, e nel bacino di raffreddamento della centrale – dove l’acqua era sempre calda per gli scarichi dell’impianto – alcuni abitanti di Pryp’jat’ stavano passando la notte a pescare: essi sentirono una successione di potenti esplosioni – diversi pensarono a un aereo che aveva superato la barriera del suono – e videro svilupparsi l’incendio. In pochi pensarono a qualcosa di veramente grave: gli operai al reattore 5 finirono il turno, i pescatori rimasero fino al mattino, fiduciosi che qualcuno si stesse occupando del problema.
2. «C’è un incendio al reattore»
La mattina successiva, la vita a Pryp’jat’ riprese normalmente: a meno di tre chilometri dal reattore, il marito di Nadezhda andò dal barbiere; suo figlio a scuola; i bambini giocarono nei parchi e negli asili; sedici coppie della gioventù comunista si unirono in matrimonio. I preparativi per la festa del Primo Maggio erano già in corso. Ma già alle otto del mattino le strade della città si riempirono di poliziotti e militari. Su alcuni, come Nadezhda, la vista dei soldati ebbe un effetto tranquillizzante: se l’esercito si sta prendendo cura della situazione, pensava, vorrà dire che è tutto sotto controllo. Gli abitanti guardavano con un certo stupore i soldati e gli agenti, molti dei quali indossavano una mascherina. Qualcuno, non molti per la verità, decise che la situazione era troppo strana, caricò armi e bagagli in macchina e lasciò la città un fine settimana nelle case di campagna.
Quella stessa mattina di sabato, Lyudmilla Ignatenko si stava chiedendo che fine avesse fatto suo marito Vasilij. Aveva ventitré anni e si era sposata da poco. Abitava al secondo piano della stazione dei pompieri di Pryp’jat’, insieme ad altre tre coppie giovani: piccoli appartamenti con la cucina in comune. Nelle prime ore del mattino, Lyudmilla aveva sentito un rumore. Si era affacciata alla finestra e aveva visto Vasilij, che le aveva detto: «Chiudi la finestra, torna a dormire. C’è un incendio al reattore. Torno presto». Stava andando alla centrale, con addosso la semplice camicia della divisa. Alle sette del mattino, Vasilij non era ancora tornato, e qualcuno avvertì Lyudmilla che era in ospedale. La ragazza vi si precipitò: davanti all’ingresso trovò le mogli di tutti quelli che, quella notte, lavoravano alla centrale. La polizia aveva circondato la zona e non lasciava passare nessuno, solo le ambulanze. Quando ne arrivò una, i poliziotti gridarono di stare lontani e di non toccarla, perché era radioattiva. Che cosa era successo alla centrale?
3. Il reattore
Abbandoniamo per un momento l’Ucraina e spostiamoci molti chilometri a nord e qualche ora più tardi, alla centrale nucleare svedese di Forsmark, un centinaio di chilometri a nord di Stoccolma. Il 27 aprile, il controllo di routine del livello di radioattività sui dipendenti arrivati per cominciare il turno fece scattare gli allarmi. La centrale venne evacuata, temendo una fuga di materiale radioattivo, ma quando altri impianti nucleari svedesi riportarono eventi simili, e anche Norvegia, Finlandia e Danimarca registrarono un livello di radiazioni inspiegabilmente alto nei propri cieli, l’attenzione si rivolse all’Unione Sovietica, da cui in quei giorni spiravano i venti.
La Svezia, attraverso la sua ambasciata a Mosca, chiese spiegazioni all’Unione Sovietica fin dalla mattina del 28. Le autorità sovietiche negarono l’incidente fino alla sera, quando un comunicato di cinque righe che riconosceva un «incidente» venne letto durante il telegiornale delle nove. L’agenzia di stampa sovietica TASS disse anche che si trattava del primo incidente in un impianto del paese – una spudorata menzogna – e ancora trentasei ore dopo l’incidente tutto quello che l’URSS aveva comunicato al mondo (e ai suoi stessi cittadini) su quanto accaduto a Černobyl’ ammontava a due dichiarazioni, per un totale di meno di duecentocinquanta parole. Ma il 30 aprile, in un lampo di inusuale franchezza, l’episodio venne definito un “disastro” dalla radio di stato sovietica e il 6 maggio la Pravda pubblicò il primo resoconto esteso di quanto avvenuto in Ucraina.
Il reattore dell’Unità 4 era del tipo RBMK, un enorme cilindro di quattordici metri di diametro per sette di altezza, riempito al suo interno dal combustibile nucleare, in larga parte uranio, e dal moderatore. Il moderatore è un materiale che serve ad aumentare il numero delle fissioni nel combustibile e quindi la produzione di energia. Nel caso dei reattori RBMK è grafite, un minerale del carbonio.
Per tutta la sua altezza, il reattore è attraversato da cilindri cavi in cui scorrono le barre di controllo: quando le barre sono completamente abbassate, il reattore è spento; più sono alzate, maggiore è la potenza del reattore. I reattori RBMK sono relativamente economici, facili da costruire e molto potenti; hanno però gravi problemi di progettazione. Uno riguarda proprio le barre di controllo, su cui torneremo a tempo debito; un altro coinvolge il reattore stesso. Nei moderni impianti nucleari, il nocciolo è contenuto in un cilindro di metallo spesso decine di centimetri e quasi indistruttibile. La sua funzione è quella di impedire che il combustibile nucleare si disperda nell’ambiente circostante in caso di problemi nel nocciolo; ad ogni modo, altre due strutture in muratura lo circondano come in una matrioska per isolare l’ambiente esterno dalle radiazioni e dal calore, e da schermo contro agenti esterni.
A Černobyl’, invece, il sistema a matrioska manca del tutto. Il nocciolo è circondato soltanto da spesse pareti di cemento armato ai lati, con un pesante scudo di metallo sopra e sotto. Ma c’è un’altra barriera che manca, nei reattori RBMK: un adeguato edificio di contenimento. Nei paesi occidentali, la struttura in cui si trova il reattore è progettata per resistere all’urto di un aeroplano a centinaia di chilometri all’ora. A Černobyl’, invece, la struttura non è in grado di resistere a sollecitazioni molto inferiori. Infine, il reattore RBMK è raffreddato ad acqua. L’acqua entra nel reattore dal basso e scorre attraverso il nocciolo, per trasportare fuori l’enorme calore prodotto dalla fissione nucleare. Quando arriva in cima si è trasformata parzialmente in vapore, che viene separato dall’acqua e serve a muovere la turbina.
Mentre in altri tipi di reattore, moderati e raffreddati ad acqua, se il flusso di acqua si interrompe le reazioni nucleari nel nocciolo calano – il moderatore non fa più il suo mestiere di facilitarle – e il reattore diminuisce di potenza, in un reattore RBMK la grafite rimane ferma al suo posto e la reazione continua, senza però che niente porti via il calore prodotto: in altre parole, la potenza aumenta – e la situazione diventa più rischiosa.
I motivi per cui il progetto degli RBMK sovietici è così evidentemente inadeguato agli standard di sicurezza in uso nel resto del mondo sono diversi: da un lato, si vogliono abbassare i costi, e dall’altro si ha piena fiducia del fatto che le procedure di sicurezza per evitare ogni grave incidente vengano seguite alla lettera. L’incidente della primavera del 1986 esporrà davanti a tutto il mondo quanto la fiducia fosse malriposta – e quanto giocasse un ruolo anche l’assoluto disprezzo per la vita umana e la sicurezza ambientale che fu una costante del nucleare sovietico. I reattori di tipo RBMK, nel 1986, hanno già alle spalle una lunga storia di incidenti – il 9 settembre 1982, nell’Unità 1 di Černobyl’ avvenne una parziale fusione del nocciolo – ma i problemi di progettazione sono stati per lo più ignorati. Anatoliy Diatlov, uno dei protagonisti – e maggiori responsabili – dell’incidente del 1986, non aveva tutti i torti quando dichiarò, dopo il disastro, che l’RBMK era «condannato ad esplodere».
4. Il test dell’inerzia
All’una di notte di venerdì 25 aprile, quasi ventiquattr’ore esatte prima dell’incidente, i tecnici dell’Unità 4 cominciarono a ridurre la potenza del reattore, che stava operando regolarmente. La direzione dell’impianto aveva deciso di condurre un test, nella sera di venerdì, per comprendere quanto a lungo la turbina principale, che generava elettricità con il vapore ad altissima pressione che usciva dal reattore, continuasse a girare nel caso di una mancanza generalizzata di energia in tutto l’impianto, una grave situazione in cui le pompe dell’acqua di raffreddamento rischiavano di interrompere improvvisamente il flusso attraverso il reattore.
La potenza residua della turbina, nello scenario immaginato dal test, doveva servire a tenere accesi ancora per qualche tempo le pompe e i dispositivi di sicurezza, prima che entrassero in funzione i generatori diesel d’emergenza: e lo scopo dell’esperimento era capire quanto a lungo.
Concettualmente, questo “test dell’inerzia” non è diverso dallo spegnimento del motore di un’auto in corsa per misurare quanta strada si continua a fare. Si trattava di un esperimento rischioso e alcuni altri impianti a cui era stato proposto avevano rifiutato; nei quattro anni precedenti era stato provato all’Unità 3, senza successo, ma da allora gli ingegneri avevano fatto qualche modifica agli impianti.
Per prima cosa, la potenza del reattore doveva essere diminuita inserendo a poco a poco le 211 barre di controllo. Per simulare lo spegnimento improvviso, i tecnici di Černobyl’ avevano poi in programma di chiudere le valvole della condotta principale dal reattore alla turbina, in modo da interrompere il flusso di vapore che la faceva girare. In queste circostanze eccezionali, ci possono essere improvvisi sbalzi di pressione nel reattore. Un calo improvviso fa scattare l’allagamento automatico del reattore con l’acqua di raffreddamento di emergenza; un aumento, invece, fa entrare in funzione la procedura automatica di spegnimento del reattore. Entrambe le procedure avrebbero obbligato poi a un blocco delle attività per parecchie settimane, e per evitarlo i tecnici disattivarono diversi sistemi di controllo: alle due del pomeriggio del 25 aprile, in particolare, l’impianto di raffreddamento d’emergenza.
Il test si sarebbe dovuto effettuare nella serata di venerdì, ma dal gestore della rete elettrica di Kiev arrivò la richiesta di ritardare la diminuzione di potenza del reattore: una stazione intermedia aveva avuto dei problemi e si chiedeva a Černobyl’ di mantenere stabile la produzione di energia. La riduzione venne quindi sospesa, ma il sistema di raffreddamento venne tenuto scollegato, in una grave violazione delle procedure di sicurezza. Non sarebbe stata la prima.
5. Il turno di notte
Il test riprese intorno alle 23.10 del 25 aprile e il rinvio fu uno dei tanti particolari che concorsero al disastro, perché alla squadra dei tecnici più esperti si sostituì quella del turno di notte, che si trovò inaspettatamente a dover condurre il test. A mezzanotte ci fu il cambio: la responsabilità dell’Unità 4 passò a Aleksandr Akimov, mentre l’ingegnere responsabile della gestione del reattore diventò Leonid Toptunov, un ragazzo di 26 anni.
Nella stanza di controllo, distante dalla sala del reattore alcune centinaia di metri, c’erano dodici persone, alcune delle quali presenti per assistere al test; anche Yuriy Tregub, capo del turno precedente, era rimasto per curiosità. Il responsabile dell’esperimento era nominalmente Gennadiy Metlenko, rappresentante della società Dontekhenergo, ma il capo delle operazioni era un 55enne di corporatura snella, con i capelli grigi accuratamente pettinati e gli occhi spenti incavati nel viso.
Anatoliy Stepanovich Dyatlov era il vice di Nikolai M. Fomin, capo ingegnere della centrale; il piano tecnico del test era stato approvato da entrambi. Chi lavorava con Dyatlov ne parlava come di un uomo dal carattere complesso e scostante, con cui era difficile avere a che fare. Era figlio di un pescatore siberiano ed era scappato di casa a quattordici anni. Fisico di formazione, arrivò a Černobyl’ a metà del 1973, senza esperienza in centrali nucleari, e al suo arrivo non conosceva nel dettaglio la struttura di un reattore moderato a grafite. Aveva portato alla centrale molti supervisori che avevano lavorato con lui nell’Estremo Oriente sovietico. Fomin, il suo superiore, non era presente quella sera: pochi mesi prima aveva avuto un grave incidente stradale e, nonostante fosse tornato a lavorare il 25 marzo, sembrava ancora molto provato dalla convalescenza. Non era presente neppure Bryukhanov, il direttore della centrale. In gran parte delle ricostruzioni dell’incidente, il brutto carattere di Dyatlov e l’incompetenza della squadra con cui lavorava sono indicate tra le cause principali di quanto successe quella notte.
Secondo il programma dell’esperimento, il test di inerzia della turbina doveva avvenire quando il reattore era a una capacità di 700-1000 MW, un terzo del massimo. Le barre di controllo, che servivano a controllare il numero di reazioni nucleari nel reattore, potevano essere gestite tutte insieme o in gruppi più ristretti, ma in quella situazione di bassa capacità diversi sistemi di controllo locale erano disattivati, come prescrivevano le regole. In quelle circostanze relativamente inusuali, Toptunov non riuscì a gestire bene l’abbassamento delle barre di controllo, causando in breve tempo la riduzione della capacità del reattore da circa metà della norma, 1500 MW, a soli 30 MW. Nel reattore cominciarono a prodursi in quantità pericolosi risultati della fissione dell’uranio, in particolare iodio e xeno. È il cosiddetto “avvelenamento”: i prodotti di fissione assorbono più neutroni della norma e rendono molto più difficile sostenere la reazione a catena – e tenere sotto controllo la potenza del reattore.
A quel punto, l’esperimento poteva considerarsi fallito. Era impossibile ristabilire facilmente le condizioni normali, come compresero subito i tecnici più esperti delle particolarità di un reattore nucleare: Toptunov, Akimov e Dyatlov. Bisognava spegnere completamente il reattore e aspettare che i prodotti della fissione decadessero. Toptunov disse che non avrebbe aumentato di nuovo la potenza per riprendere il test, non sentendosi più in grado di gestire la situazione. Ma Dyatlov non sembrava in grado di prendere atto della situazione e interrompere tutto, anche a causa del suo carattere difficile: cominciò ad andare da un pannello di controllo all’altro, dando degli incompetenti ai suoi sottoposti. Disse che se Toptunov si rifiutava di aumentare la potenza lo avrebbe fatto Tregub, del turno precedente.
Toptunov, alla fine, cedette alle pressioni del responsabile dell’esperimento – un uomo duro e scostante, che aveva il doppio dei suoi anni – e cominciò ad aumentare la potenza. Per farlo, ritirò quasi tutte le barre di controllo, in un numero ben maggiore al margine indicato come sicuro. Gli ci volle quasi un’ora per riportare la potenza stabilmente intorno ai 200 MW; a quel punto, l’escursione di potenza possibile non permetteva più di spegnere il reattore con le barre rimaste. Ma i responsabili del test pensarono di essere in grado di gestire la rischiosissima situazione, e che il reattore non li avrebbe traditi.
6. Le barre di controllo
E qui entra in gioco un altro cruciale difetto di progettazione del reattore di tipo RBMK. Il nocciolo era alto sette metri, mentre la parte delle barre di controllo in grado di assorbire i neutroni in eccesso erano di cinque metri, con un metro inerte sopra e sotto di esse. La parte inferiore delle barre era di grafite, lo stesso materiale usato come moderatore, che ha l’effetto di abbassare la velocità di fuga dei neutroni e aumentare la probabilità che si scontrino con altri nuclei.
Al momento dell’inserimento delle barre, quindi, entrava nel nocciolo un’altra sezione di grafite, poi un metro inerte, infine i cinque metri in grado di assorbire neutroni: l’ingresso causava insomma un improvviso aumento delle reazioni nucleari, dovuto al potere moderante della grafite – un evento già poco felice quando il reattore era stabile e sotto controllo – e solo successivamente un assorbimento.
All’una di notte del 26 aprile, quasi duecento barre di controllo erano completamente sollevate sopra il reattore. Erano l’estremo strumento per riprendere in mano la situazione, ma il difetto di progettazione le rendeva tragicamente adatte a causare una serie di reazioni incontrollate. In quei minuti concitati non venne in mente a nessuno. Non venne in mente ad Akimov, che fino alla sua morte due settimane più tardi continuò a ripetere a chiunque fosse a tiro – compresi i suoi familiari al capezzale – che tutto era stato fatto secondo le regole e che non riusciva a capire che cosa fosse andato storto.
All’una e sette minuti del 26 aprile, un quarto d’ora prima dell’incidente, tutte le pompe idrauliche per il raffreddamento del reattore vennero fatte entrare in funzione per far scorrere più acqua nel nocciolo, dato che forzare l’aumento della potenza nel reattore “avvelenato” rischiava di causare un pericoloso accumulo di calore. Fu l’ennesima violazione delle regole di sicurezza, perché il flusso totale dell’acqua venne aumentata dai normali 45 mila metri cubi l’ora a circa 60 mila. Questo mise sotto stress il sistema idraulico, con il pericolo di causare pericolose vibrazioni delle tubature. All’una e 22 minuti Toptunov vide nero su bianco, in una pagina stampata dal sistema di controllo computerizzato SKALA, che le barre di controllo nel reattore erano troppo poche per gestire in modo sicuro il reattore. In condizioni normali, i sistemi di emergenza avrebbero spento automaticamente tutto: ma quei sistemi erano stati disattivati. Sul fondo del grande cilindro, il calore si stava accumulando pericolosamente; la crescita di potenza era un segnale grave che qualcosa stava andando storto; ma nessuno, nella sala di controllo, diede il comando di interrompere il test. Visti i parametri completamente sballati, portare a termine il test non avrebbe comunque portato a nessuna rilevazione utile. Si proseguì lo stesso.
7. Il disastro
All’una, 23 minuti e quattro secondi uno degli ingegneri responsabili della turbina, Igor Kershenbaum, eseguendo un comando di Metlenko, chiuse una valvola e interruppe il flusso di vapore diretto alla turbina, dando inizio alla fase cruciale. Contemporaneamente, i due generatori che fornivano elettricità al sistema vennero spenti premendo un pulsante nella sala di controllo. Nello stesso istante, le condutture collegate alle pompe principali cominciarono a riempirsi di vapore, che non poteva sfogarsi nella turbina. Dove ci sarebbe dovuta essere acqua per raffreddare il reattore, ora c’erano pericolose sacche di vapore e il calore non veniva asportato adeguatamente, il che causò un ulteriore innalzamento della temperatura.
La situazione stava sfuggendo di mano, la sala di controllo risuonava dei segnali di allarme: Aksimov decise che bisognava utilizzare l’estrema procedura di emergenza di far calare tutte le barre di controllo nel reattore, il cosiddetto scrab. Lo annunciò ad alta voce nella sala di controllo. All’una, ventitré minuti e quaranta secondi il capoturno Aleksandr Aksimov premette il pulsante che diede il segnale alle duecento barre di scivolare nel reattore in modo controllato. Queste si fermarono, bloccandosi, dopo essere penetrate circa due metri e mezzo invece dei sette previsti.
Nell’enorme sala centrale, quella del reattore, si sentì una serie di spaventosi colpi sordi. Akimov premette un altro pulsante che avrebbe dovuto far calare le barre nel nocciolo in virtù del loro stesso peso. Ma non si mossero. Erano rimaste incastrate, le cavità in cui dovevano scorrere ormai deformate dal calore. Il metro di grafite all’estremità delle barre, progettato per sporgere dal lato inferiore dopo l’inserimento completo, causò un improvviso aumento delle reazioni nucleari.
Il disastro si sviluppò in pochi secondi. All’interno della sala centrale, in quel momento, c’era un tecnico di nome Valeriy Ivanovich Perevozchenko. Si trovava su una piattaforma a cinquanta d’altezza, poco sopra il coperchio superiore del reattore – un disco di roccia e metallo alto tre metri detto “muso” – e l’ulteriore strato di protezione formato da duemila blocchi di acciaio e grafite pesanti 350 chilogrammi l’uno. Davanti agli occhi di Perevozchenko, i blocchi cominciarono a saltare su e giù, come sassolini che tremano al passaggio di un treno. Che cosa succedeva dentro al reattore?
La mancanza di elettricità nelle pompe aveva causato una caduta nel flusso d’acqua di raffreddamento e un altro innalzamento improvviso della temperatura; l’acqua fu divisa dal violento aumento delle radiazioni, e l’idrogeno creò una miscela esplosiva insieme ai prodotti di reazione della grafite. La pressione nei canali del reattore e nelle tubature sopra e sotto il reattore cominciò a salire al devastante ritmo di quindici atmosfere al secondo e le valvole di sicurezza per scaricare il vapore in eccesso si ruppero quasi istantaneamente. All’una, ventitré minuti e cinquantotto secondi una prima esplosione distrusse gran parte del combustibile nucleare, delle barre di controllo e delle condutture dell’acqua, rimanendo all’interno delle pareti del nocciolo ma facendo saltellare i blocchi da 350 chili.
Anche se non poteva sapere tutto questo, Perevozchenko capì che stava succedendo l’irreparabile: volò per i quaranta metri di scale fino alla base della sala e imboccò il primo corridoio verso la sala di controllo dell’Unità 4, che si trovava in fondo a un altro corridoio lungo un centinaio di metri.
Prima che ci arrivasse, la concentrazione di idrogeno raggiunse i livelli critici e ci fu una serie di potenti esplosioni del reattore – almeno due – che sollevarono l’enorme coperchio e lo lasciarono di traverso sul reattore, distrussero il tetto in cemento armato della sala del reattore e catapultarono verso l’esterno parte del combustibile nucleare, della grafite e delle strutture intorno al cilindro. I pezzi incandescenti caddero sul tetto in asfalto del locale della turbina, adiacente a quello del reattore, dandogli fuoco. Il reattore era ora esposto all’aria.
Circa cinquanta tonnellate di materiale nucleare – dieci volte il peso totale della bomba sganciata su Hiroshima – furono scagliate nell’atmosfera in una colonna alta un chilometro, nella forma di diossido di uranio, iodio-131, plutonio-239, nettunio-139, cesio-137 e stronzio-90, insieme a una quantità di altri isotopi radioattivi. Altro materiale proveniente dal nocciolo, per un totale di circa settecento tonnellate, si sparse nel terreno attorno alla centrale e sui tetti delle strutture dell’Unità 4. Un solo operaio della centrale, Valeriy Khodomchuk, fu ucciso dall’esplosione: si trovava in un locale adiacente alla stanza del reattore che ora, visto dall’alto, era un vulcano di combustibile altamente radioattivo e di centinaia di tonnellate di grafite in fiamme. Da Pryp’jat’ il reattore 4 appariva avvolto in un’aura luminescente, sulle tonalità del rosso. Una grande nuvola radioattiva cominciò il suo viaggio attraverso la foresta di pini che separava l’area industriale dalla città – i pini di quella che sarebbe diventata nota in tutto il mondo come la Foresta Rossa avrebbero cambiato colore e sarebbero tutti morti prima dell’autunno.
***
8. La Zona
La sera del 26 aprile, una ventina di ore dopo l’incidente, le finestre della città rimasero chiuse, come da ordini delle autorità; nel frattempo, le autorità locali si erano rese conto che i livelli di radiazione in diverse parti della città erano totalmente fuori controllo. In alcune parti di Pryp’jat’, un uomo all’aria aperta avrebbe raggiunto in mezz’ora il limite di radiazioni ritenuto sicuro per l’uomo in un anno, 500 roentgen (il roentgen non è più una misura utilizzata per misurare le radiazioni, ma poiché è utilizzata in gran parte delle ricostruzioni dell’incidente la manterremo anche qui). Gli abitanti della città rischiavano di arrivare tutti, nell’arco di una settimana, a ricevere una dose potenzialmente letale.
Pryp’jat’ venne evacuata solo a partire dalle due del pomeriggio del 27 aprile: per un giorno e mezzo, gli abitanti erano stati tenuti all’oscuro della gravità della situazione. Milleduecento autobus furono portati da Kiev e vennero riempiti degli abitanti della città nell’arco di poche ore. La fila dei mezzi in uscita dalla città era lunga quindici chilometri. Nonostante fosse stato annunciato per radio che l’evacuazione sarebbe durata solo tre giorni, gli abitanti non fecero mai ritorno: il livello di radiazione la rende inabitabile ancora per centinaia di anni.
Oltre a Pryp’jat’ e a Černobyl’ – evacuata il 5 maggio – centosettantanove villaggi e insediamenti circostanti, spesso centri agricoli che, come scrisse un inviato del New York Times, erano «scampoli della vita del XVIII secolo» – vennero svuotati dei loro abitanti tra il 29 aprile e il 9 maggio. Case, alberi e rifiuti radioattivi vennero sepolti dai bulldozer in ottocento siti all’interno della Zona. Alcuni villaggi vennero completamente cancellati: veniva scavata una fossa davanti a ciascuna casa e poi i mezzi pesanti ci buttavano dentro l’intera costruzione. Poi riempivano di nuovo la buca e spianavano il terreno. Operazioni come questa furono pensate ed eseguite nella fretta di sistemare le cose dopo il disastro, anche se secondo alcuni non hanno fatto altro che depositare ancora più in profondità i materiali radioattivi nel suolo, minacciando le falde acquifere.
Migliaia e migliaia di cani, di gatti, di cavalli e di capi di bestiame vennero uccisi da apposite squadre: gli animali da carne e da latte producevano ormai alimenti tossici, gli animali domestici rischiavano di vagare fuori dalla Zona e di contaminare gli uomini.
Le autorità stabilirono una zona di esclusione di trenta chilometri quadrati intorno alla centrale, in cui non è possibile, tuttora, circolare liberamente. Le zone pesantemente contaminate si alternano ad altre in cui le radiazioni sono relativamente normali, seguendo uno schema a macchia di leopardo che dipende dai venti e dalle piogge dei primi giorni. Per evitare il panico tra la popolazione, e agendo in base a quello che molti valutano come un totale disprezzo della vita umana e delle regole delle autorità internazionali, le autorità ucraine e sovietiche incoraggiarono comunque lo svolgimento dei grandi festeggiamenti del Primo maggio anche in zone che sapevano contaminate e in città già raggiunte dalla nube radioattiva, come Kiev.
Nonostante questo, la centrale rimase ferma solo pochi mesi (l’Unità 1 venne riaccesa a settembre del 1986) e cinque anni dopo l’incidente tutti e tre i reattori rimasti erano di nuovo in funzione. Circa diecimila persone lavoravano alla centrale e all’interno della Zona e una nuova città, Slavutich, era stata costruita 70 chilometri ad est per ospitarli – migliaia di persone facevano i pendolari quotidianamente nella Zona.
Dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica e l’indipendenza ucraina, il governo locale disse per molti anni di essere disposto a spegnere quel che restava di Černobyl’: a patto, però, che la comunità internazionale contribuisse alle spese per trovare fonti di energia alternative, come la costruzione di altre due nuove e moderne centrali nucleari. A dicembre del 2000, il presidente ucraino Kuchma spense durante una cerimonia ripresa dai media di tutto il mondo l’ultimo reattore di Černobyl’ rimasto in funzione.
La nube radioattiva si sparse dall’Ucraina in gran parte dell’Europa centro-settentrionale, portata dai venti. Il divieto di commerciare liberamente le pecore al pascolo in centinaia di fattorie del Galles settentrionale è stato revocato solo a marzo del 2012: inizialmente, 4 milioni di capi di bestiame inglese vennero posti sotto osservazione. Ma il paese che ha sofferto maggiormente le conseguenze ambientali dell’incidente è stata la Bielorussia, dove si stima che si sia posato il settanta per cento dei radionuclidi dispersi nell’atmosfera. Černobyl’ fu un vero e proprio disastro nazionale, per un paese che non ha mai avuto un impianto nucleare: un abitante su cinque vive in aree a diverso livello contaminate dalle radiazioni, per un totale di oltre due milioni di persone; 485 paesi o località sono disabitate in conseguenza dell’incidente, un centinaio in meno dei villaggi distrutti dall’avanzata dell’esercito nazista durante la Seconda guerra mondiale.
Le stime dei casi di malattie gravi causate da Černobyl’, in Bielorussia e altrove, variano moltissimo a seconda di chi le ha compiute, da un massimo di quattromila secondo l’Organizzazione mondiale della sanità a molte decine di migliaia. Altre migliaia di persone, tra cui molti “liquidatori”, sono state rese invalide dalle malattie legate alle radiazioni o hanno sofferto seri impedimenti nella loro vita quotidiana: Černobyl’, è stato notato, ha causato poche decine di vittime e centinaia di migliaia di sopravvissuti. Il dibattito sulle reali conseguenze per la salute delle popolazioni esposte alle radiazioni, o che tuttora vivono in aree contaminate, è molto acceso e nessuno sembra poter dire la parola definitiva.
L’unica conseguenza accertata è un aumento dell’incidenza dei casi di cancro alla tiroide – un male curabile se diagnosticato in tempo e raramente mortale – in chi era bambino all’epoca dell’incidente e venne esposto alle radiazioni; lo iodio-131, l’isotopo radioattivo principalmente responsabile, ha un’emivita di soli otto giorni e dunque si dissolse quasi completamente nell’arco di poche settimane dall’incidente.
***
9. Negazioni
La negazione della realtà, anche di fronte all’evidenza più schiacciante, è un comportamento umano molto comune – e insieme difficile da comprendere, quando analizzato razionalmente. La reazione al disastro da parte dei responsabili dell’impianto, nelle prime ore, fu un misto di incredulità, incompetenza e irresponsabilità che rivaleggiò negli effetti con l’incidente stesso. Dopo la serie delle devastanti esplosioni, l’elettricità saltò in tutto l’impianto e rimasero accese soltanto alcune luci di emergenza, lasciando la sala di controllo nella semioscurità.
Nella sala di controllo si convinsero – vollero convincersi – che l’esplosione fosse avvenuta in uno dei serbatoi di emergenza e che il reattore fosse ancora intatto. Dalla sala di controllo partirono due giovani ingegneri, Viktor Proskuryakov e Aleksandr Kudryavtsev, con l’istruzione di abbassare a mano le barre di controllo. Attraversarono la semioscurità dei corridoi debolmente illuminati, ma rimasero nella sala del reattore – che ormai per soffitto aveva le stelle – meno di un minuto, poi tornarono dicendo che la copertura del reattore non c’era più, con il viso già arrossato dal calore e dalle radiazioni (sarebbero morti pochi giorni dopo). Dyatlov e gli altri non vollero credere loro e si dissero che dovevano aver visto male: il reattore doveva essere intatto. Arrivò nella sala di controllo anche Perevozchenko, l’uomo che aveva visto saltellare i blocchi da 350 chili: anche lui disse che il reattore era distrutto senza essere creduto.
Il direttore dell’impianto Bryukhanov, colui che aveva voluto l’esperimento, fu svegliato con una telefonata e arrivò sulla scena intorno alle 2.30. Akimov disse che c’era stata un’esplosione in un serbatoio, ma che il reattore era intatto. Bryukhanov tirò un sospiro di sollievo e chiese informazioni sul livello delle radiazioni. Gli fu risposto che l’unico rilevatore disponibile – tutta la strumentazione della sala di controllo era fuori uso – indicava un livello di 3,6 roentgen l’ora: alto, ma non letale se non nell’arco di molte ore. Ironia della sorte, i dosimetri più potenti erano chiusi in un armadio di cui nessuno sembrava aver le chiavi, e quando se ne trovò un altro che segnava 250 roentgen l’ora decisero che era guasto. In realtà, il livello nelle zone più contaminate dell’impianto era circa cento volte superiore.
L’ordine a tutti gli uomini disponibili fu di continuare a pompare acqua nel reattore con ogni mezzo possibile, una mossa totalmente inutile vista la distruzione del reattore e che ebbe l’unico effetto di riempire quel che restava della sala del reattore di acqua radioattiva. Bryukhanov chiamò poco dopo a Mosca. C’era stato un grosso incidente all’Unità 4, ma il reattore era intatto. Stavano continuando a pompare acqua per mantenerlo raffreddato. Da Mosca risposero: continuate a pompare acqua fino a nuovo ordine. Akimov e Toptunov si comportarono di conseguenza e rimasero per ore immersi in mezzo metro d’acqua radioattiva, azionando a mano valvole e manopole di un sistema idraulico che non serviva ormai più a nulla. Furono portati in ospedale allo stremo delle forze. Bryukhanov e Fomin rifiutarono di prendere atto della realtà fino a parecchie ore più tardi.
Nel frattempo il primo gruppo di vigili del fuoco, comandata dal 23enne Vladimir Pravik, era arrivato all’Unità 4 dopo pochi minuti. Per cercare di valutare la gravità della situazione, si arrampicarono sul tetto di una struttura vicina, guardando direttamente nel cratere. Camminarono a lungo sul tetto del locale delle turbine, che per un altro tragico errore di costruzione era coperto di bitume infiammabile e non di materiale ignifugo, e sopra i pezzi di combustibile e grafite in fiamme, senza alcuna protezione.
Nessuno li aveva avvertiti che il reattore era stato danneggiato – perché nessuno, nella sala di controllo, voleva crederci – e la radioattività non si vede. Ma dopo pochi minuti i vigili del fuoco, tra cui Vasilij Ignatenko, cominciavano ad avere la nausea, le vertigini e un intollerabile bruciore agli occhi: si stima che sul tetto del locale turbine il livello delle radiazioni fosse allo stratosferico livello di 20.000 roentgen l’ora, quando la dose ritenuta fatale per l’uomo è decine di volte inferiore, 500 roentgen nell’arco di cinque ore. Molti di loro resistettero a lungo, riuscendo a spegnere tutti gli incendi escluso quello del reattore prima delle sette del mattino e impedendo l’espandersi degli incendi alle altre unità della centrale – tutte raggruppate intorno al locale delle turbine. Per questo ogni racconto del disastro gli attribuisce un ruolo da eroi. Alle sette del mattino erano arrivate una quarantina di squadre da tutta l’area di Kiev. Decine di vigili del fuoco sarebbero morti per eccessiva esposizione alle radiazioni nell’arco di poche settimane.
***
10. Conseguenze
La risposta al disastro dell’Unione Sovietica, dopo i primi tragici errori di valutazione, fu un misto di eroismo e disperazione. Nei giorni successivi, migliaia e migliaia di militari e membri della guardia nazionale vennero trasportati nell’area della centrale, nonostante i piani per contrastare le conseguenze dell’incidente fossero tutt’altro che chiari. Gli elicotteristi dell’Armata Rossa effettuarono decine di voli sopra il cratere del reattore, portando a bordo soldati che, a mani nude, lanciavano mirando a vista sacchi di sabbia e di acido borico – e più tardi di piombo – per cercare di assorbire le radiazioni provenienti dal nocciolo e soffocare l’incendio.
Decine di loro ricevettero dosi letali di radiazioni, mentre delle tonnellate di materiali lanciate in questo modo nei primi giorni assai poche riuscirono realmente a centrare il reattore. È tuttora discusso se i lanci di sabbia siano stati una buona idea o abbiano peggiorato la situazione. In un misto di cinismo e disperazione, i vertici scientifici e militari della commissione governativa incaricata di gestire la situazione cominciò a valutare le diverse opzioni «contando le vite» – stimando a spanne quante persone sarebbero morte per portarle avanti.
Per giorni e giorni le radiazioni emesse dal reattore continuarono ad aumentare per effetto dell’incendio e dello scioglimento dei materiali. Poi, il 6 maggio 1986, il fuoco del reattore si estinse e con esso le emissioni più massicce nell’atmosfera. Parte del combustibile si era mischiato alla sabbia ed era colato nelle fondamenta della struttura, condensandosi in una massa vetrosa pesante diverse tonnellate che sarebbe stata scoperta solo mesi dopo nei locali sotto il reattore e soprannominata, per la sua forma, «la zampa d’elefante».
Arrivarono macchinari da tutto il mondo, insieme ad alcuni veicoli del programma spaziale sovietico progettati per le missioni lunari, per spostare il materiale radioattivo sparso sul tetto e gettarlo di nuovo dentro quel che restava della sala del reattore. Tutti si bloccarono tra i detriti o andarono in tilt a causa delle radiazioni, e il loro posto fu preso da riservisti dell’Armata Rossa volontari o che eseguirono l’ordine di partecipare alla «liquidazione» delle conseguenze dell’incidente, da cui il nome ufficiale, “liquidatori”.
Il loro compito consisteva nel correre in piccole squadre di quattro-sei persone sul tetto del reattore numero 3, sollevare manualmente un blocco di grafite altamente radioattiva pesante una cinquantina di chilogrammi e buttarlo in basso, oltre l’orlo del tetto distrutto, e all’occasione fare lo stesso con i detriti, usando una pala. Erano protetti con artigianali camici di piombo che li ricoprivano in qualche modo. L’intera operazione doveva durare, secondo quanto dicevano i superiori alle squadre, al massimo un minuto. Le foto dei soldati sul tetto mostrano spesso strisce verticali scolorite per effetto delle radiazioni che provenivano dal terreno.
Al termine, ricevevano un attestato nei locali sotto il tetto e venivano mandati a casa con cento rubli. In operazioni simili a quella vennero impiegate, nell’arco di diversi mesi, circa 240 mila persone che ricevettero la dose totale di radiazioni ritenuta critica per una intera vita. Il titolo di “liquidatori” venne concesso a un totale di seicentomila persone variamente impiegate nelle fasi successive al disastro.
Migliaia di minatori, molti della regione di Tula, a ottocento chilometri di distanza, vennero prelevati in tutta fretta e portati a Černobyl’, dove arrivarono il 13 maggio, per costruire una stanza sotterranea alta due metri e larga trenta sotto il reattore: venne riempita di cemento per evitare che il combustibile fuso colasse fino all’enorme bacino d’acqua nel terreno sotto la centrale, contaminando in modo irreparabile le riserve idriche di cui si servivano milioni di persone. I minatori, tutti ragazzi tra i venti e i trent’anni, riuscirono nel compito di scavare 13 metri di tunnel al giorno, in un calore irrespirabile ed esposti alle radiazioni.
Per coprire l’edificio del reattore fu costruita in tutta fretta una struttura alta sessantasei metri e lunga centosettanta, che tutti presero a chiamare presto – con metafora funeraria – “il sarcofago”. Il lavoro doveva essere fatto in fretta. Anche la pioggia era pericolosa, perché si temeva che l’acqua potesse innescare una reazione a catena del combustibile nucleare. A ottobre del 1986 il reattore era coperto quasi interamente, senza badare troppo ad aperture del sarcofago in cui sarebbe potuta passare un’automobile, tappate poi negli anni successivi. Quando la struttura di cemento venne chiusa, una bandiera rossa, che a molti ricordò quella issata sul Reichstag quando i sovietici occuparono Berlino, venne posta in cima alla ciminiera del reattore numero 4.
***
Pochi giorni dopo l’incidente, Lyudmilla Ignatenko ritrovò il marito Vasilij all’ottavo piano della clinica numero 6 di Mosca, l’unico ospedale del paese attrezzato per gestire le conseguenze più gravi delle radiazioni sull’uomo. Lo trovò apparentemente in buona salute, che giocava a carte e scherzava con i suoi colleghi, tutti vestiti con lo stesso pigiama; ma i medici non la lasciarono avvicinare e le vietarono abbracci o baci. Vasilij stava attraversando la cosiddetta fase di latenza: dopo un primo momento di nausea, vomito e vertigini, chi ha assorbito una dose molto alta di radiazioni si ristabilisce temporaneamente prima della drammatica ricaduta, quando sulla pelle cominciano a comparire vaste bruciature.
Lyudmilla stette di fianco al marito durante i lunghi giorni dell’agonia, lenta e straziante, causata dalla cosiddetta sindrome dell’avvelenamento acuto da radiazioni. Dopo qualche giorno venne messo in una stanza speciale, dietro una cortina; gli infermieri si rifiutavano di seguire quei pazienti senza indumenti protettivi, e il loro posto venne preso dai soldati. La pelle si staccava a strati, i capelli cadevano a ciocche, e le emorragie interne erano orribili, mentre il corpo si consumava e rattrappiva come bruciato da un fuoco interno. «Ogni giorno incontravo una persona completamente nuova», raccontò Lyudmilla anni dopo. Vasilij Ignatenko morì all’ottavo piano della clinica numero 6 di Mosca, come gran parte dei vigili del fuoco e degli operatori della centrale che subirono gli effetti più gravi delle radiazioni.
Al 10 luglio 1986, secondo i dati ufficiali, ventotto persone erano morte per l’avvelenamento acuto da radiazioni: furono sepolti a Mitino, nei pressi di Mosca, in bare di zinco, per evitare che i loro resti radioattivi penetrassero nel terreno. Bryukhanov, Dyatlov e Fomin furono arrestati nell’agosto del 1986. Insieme ad altri tre funzionari furono processati in un tribunale formalmente aperto al pubblico nel corso del 1987 – ma in una corte di Černobyl’, all’interno della zona proibita.
***
Nota sulle fonti: La ricostruzione degli eventi intorno al disastro di Černobyl’ è basata su diverse fonti, in primo luogo su The Truth about Chernobyl di Grigori Medvedev. Per quanto sia raccontato da una prospettiva a tratti molto personale e sia apparso nel 1991, è ancora oggi uno dei testi più importanti sulla vicenda. Un’ottima ricostruzione (in inglese) dell’incidente, corredata da diverse foto dell’autore, è stata pubblicata solo su Internet, a gennaio 2014, da Andrew Leatherbarrow. I materiali riguardo le storie di Vasilij e Lyudmilla Ignatenko, come quelle degli altri abitanti di Pryp’jat’, sono tratte da Voices from Chernobyl: The Oral History of a Nuclear Disaster, un libro del 2005 della giornalista bielorussa Svetlana Alexievich basato su oltre cinquecento interviste con persone coinvolte nel disastro. Dal punto di vista tecnico, la ricostruzione dell’incidente è entrata da tempo a far parte dei manuali di impiantistica nucleare: ad esempio Impianti nucleari di Carlo Lombardi (Milano, ed. CUSL, 2004). Esistono anche moltissimi documentari sul disastro e le sue conseguenze, tra cui segnalo The Battle of Chernobyl andato in onda su National Geographic. Ringrazio per l’importante e generoso aiuto nella ricostruzione degli aspetti più tecnici della vicenda Stefano Lorenzi e Nicola Ongari. Tutti gli errori e le imprecisioni sono miei.
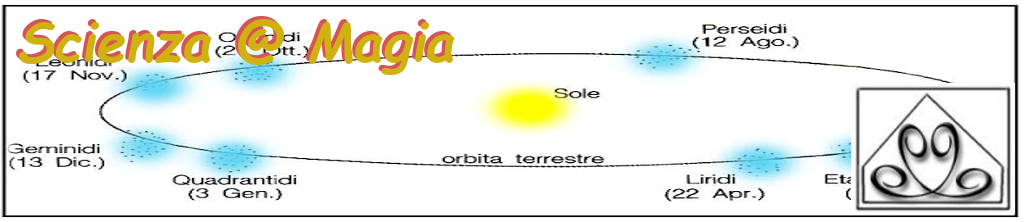
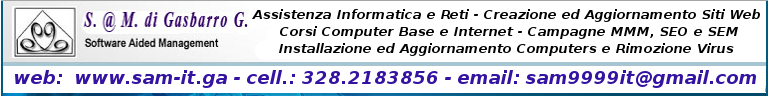


Lascia un commento