
Il fallimento del modello start-up. L’ideologia della Silicon Valley è in crisi: ecco perché l’Italia, se vuole ripartire, non deve seguirla. Nel suo discorso programmatico al Senato, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha lanciato un messaggio chiaro e di grande impatto, che si può riassumere così: «Tuteleremo tutti i lavoratori, ma non aspettatevi che salveremo tutte le aziende». Draghi crede che non abbia più senso sostenere a pioggia tutte le imprese colpite dalla pandemia e sperare per il meglio come ha fatto il secondo Governo Conte, ma che si debba lasciare fallire chi non riesce a stare sul mercato, e invece sostenere quelle aziende che sanno innovare e adattarsi ai profondi cambiamenti del mondo post-pandemia.
Tutto ciò costituisce una sorprendente analogia con la storia degli ultimi vent’anni della Silicon Valley, e nello specifico del cosiddetto “start-up system”. A prima vista potrebbe sembrare un’ottima cosa: l’Italia è un Paese molto incline all’imprenditorialità, con un numero enorme di piccole o piccolissime aziende, di cui molte si troveranno presto a chiudere e i cui imprenditori dovranno quindi reinventarsi; quale migliore opportunità di provare ad applicare su larga scala un modello di grande successo come quello californiano delle start-up per rilanciare il Paese? Eppure, sarebbe un tragico errore.

Nell’arco di poco meno di vent’anni, la parola “start-up” è passata da etichetta più desiderata da sfoggiare a un buffet metropolitano a formula in grado di far inarcare sopracciglia se non proprio alzare gli occhi al cielo durante una riunione di lavoro. E questo, ben lungi dall’essere solo effetto dell’italica diffidenza verso l’innovazione, è invece segno della perdita di forza della sua narrazione, che per l’ideologia californiana dell’innovazione dal basso è tutto, o quasi.
Il modello start-up ha cominciato a farsi largo nel mondo a partire dagli anni 2000. Il suo rapido successo fu dovuto principalmente a tre promesse: anzitutto, quella di mettere a sistema la spinta verso l’innovazione, facendola uscire dai laboratori universitari o dai centri di ricerca delle grandi aziende; poi di consentire ai migliori talenti di accedere a mezzi e capitali per farsi valere in maniera meritocratica, creando un impatto concreto sulla società; infine, di offrire ai capitali un nuovo sbocco per investimenti redditizi, rendendo più vario e un po’ più “egualitario” il mercato finanziario. Insomma: innovazione, merito, profitto.
Vent’anni dopo, si può serenamente dire – anche se, comprensibilmente, diversi tengono molto a dire il contrario – che nessuna di queste tre promesse è stata davvero mantenuta. Al netto di qualche eccezione, ciò che lo start-up system ha fin qui prodotto è stato una manciata di colossi di enorme successo finanziario ma a bassa redditività e spesso con enormi perdite economiche, una piccola popolazione di piccole imprese sussidiarie a multinazionali, sostenibili ma senza crescita o innovazione rilevante, e una messe infinita di progetti naufragati con una perdita ingente di investimenti (anche pubblici) ed enorme spreco di energie e speranze per tanti giovani.
Partiamo dall’inizio. Gli attori dello start-up system sono principalmente tre. Ci sono le start-up: piccolissime imprese appena formate, ad alta conoscenza e che pensano di poter innovare un processo o un mercato, spesso facendo leva sulla tecnologia. Poi ci sono i Venture Capital: fondi privati orientati all’investimento di alto rischio e quindi di alto ritorno, con l’obiettivo di supportare le imprese, idealmente fino alla loro quotazione in borsa. Infine ci sono una serie di intermediari: incubatori, acceleratori, business angel, che aiutano le start-up nelle prime fasi, offrendogli a seconda dei casi competenze, spazi di lavoro, o piccoli finanziamenti.
La logica iniziale dello start-up system era quella del cosiddetto “spray and pray”, ovvero sostenere una grande quantità di start-up con piccoli finanziamenti, e sperare che alcune di esse non fallissero riuscendo a stare sul mercato; ma soprattutto che una o due avessero davvero successo, innovando radicalmente il loro settore, conquistando fette di mercato importanti e quindi restituendo profitti enormi che andassero più che a compensare la ridda di piccoli investimenti iniziali. Questo modello andò per la maggiore negli anni 2000, sulla scia di un pugno di esperienze di grande successo, soprattutto nel digitale, come Facebook, YouTube, Instagram, Whatsapp, ma anche nella disintermediazione, come AirBnB e Uber.
Se non che, presto si realizzò che i conti non tornavano. Le start-up di vero grande successo erano troppo poche, e soprattutto era quasi impossibile capire all’inizio chi ce l’avrebbe fatta e chi no. L’esempio di AirBnB è particolarmente significativo in merito: gli investitori pensavano che la loro idea di business fosse terribile, ma un incubatore li supportò perché fu colpito e insieme mosso a pietà dal fatto che i tre giovani fondatori per finanziarsi vendevano scatole di cereali alle convention politiche. La start-up su cui nessuno razionalmente avrebbe investito diventò poi un’azienda da oltre 10 miliardi di dollari di valore.
Si cominciava quindi a capire che il merito c’entrava relativamente poco, e a incidere molto erano invece il tempismo, le relazioni, il capitale iniziale, le decisioni giuste… Insomma, soprattutto il caso. Di conseguenza, il modello di business non stava in piedi: gli investimenti non rendevano abbastanza. Soprattutto, al fondo ci si rendeva conto che non si faceva vera innovazione, perché sia startupper che investitori tendevano a puntare su tecnologie già esistenti, e su spazi di mercato già promettenti. Insomma, non creavano l’onda, ma la cavalcavano. Il modello era in difficoltà, e in più era scoppiata la crisi finanziaria del 2008. Ma proprio nell’ora più buia, arrivò un eroe a salvare la situazione.
Eric Ries con il suo libro “Lean Startup” introdusse un modello che diede una seconda vita allo start-up system. Cosa diceva Ries? In pratica che lo startupper non doveva lavorare a un’idea e a un business plan per poi farsi finanziare, ma andare subito sul mercato con un prototipo anche raffazzonato del suo prodotto o servizio, modellarlo sulla base delle risposte dei primi utenti o clienti e poi, solo quando funzionava, andare dagli investitori ed entrare davvero sul mercato.
Poco importava che non tutte le idee possono sviluppare un prototipo con poco investimento, o che le risposte di un mercato locale e amicale siano poco predittive del vero mercato, o ancora che i cambiamenti al prototipo (detti “pivotal”) abbiano poche garanzie di essere quelli giusti: l’importante era che il modello Lean permetteva agli investitori di scaricare quasi completamente sulla start-up il rischio di impresa, e forniva a incubatori e acceleratori un modello standard che riducesse sostanzialmente costi e processi. Inoltre, era in linea con “l’epica” dello startupper avventuriero coraggioso, dandogli la possibilità di andare oltre i grigi fogli di calcolo Excel e di misurarsi subito col mercato.
Negli anni 2010 il metodo Lean divenne il nuovo verbo di incubatori, acceleratori, venture capital, angel investor e di tutto il vasto “ecosistema” che si era creato attorno. Anzi, in un certo senso questo aumentò ancora di più, con consulenti e formatori che cercavano di applicare il “metodo start-up” in ambito industriale, portandolo anche fuori dal circuito digitale (infatti venne poi il boom delle varie “industria 4.0”, “medtech”, “fintech”, ecc.) e aprendosi nuovi spazi di mercato cavalcando una narrazione di forte fascino e successo.
Ma a 10 anni dal libro di Ries, anche l’approccio Lean si è rivelato incapace di risollevare le sorti del modello start-up. Basta guardare ai numeri: le performance dei fondi di Venture Capital negli ultimi vent’anni sono andate di pari passo con quelle dell’indice S&P500 – uno standard per valutare l’andamento economico aziendale. Quindi, nonostante un pugno di start-up di grande successo che hanno dato ricchissimi dividendi, i fondi perduti sono stati tanti e tali da fare pari e patta con la normale industria, senza quindi creare valore finanziario aggiunto.
Ma è sul lato più puramente economico che si vedono le crepe del modello. Anzi, i burroni. Anche prendendo le startup di enorme successo, i cosiddetti “unicorni” (nome che curiosamente descrive un essere che non esiste se non nel mito) la redditività è spesso per lo meno lacunosa, quando non disastrosa. Il rapporto prezzo/utili per queste aziende indica che colossi come Google e Facebook hanno una redditività dimezzata rispetto a una classica multinazionale; quella di Amazon è addirittura 10 volte meno, mentre Uber brucia miliardi di dollari all’anno.
Eppure, queste aziende hanno giri di affari enormi perché o detengono asset strategici ma dal valore discusso come i dati, o sono sulla bocca di tutti e attraggono gli investitori. Insomma, la reputazione è potere, e il potere è ricchezza. Ne hanno scritto qui su HuffPost riguardo Elon Musk, ma c’è un caso ancora più estremo a rappresentazione delle storture – per non dire contraddizioni – del modello start-up: quello di WeWork e del suo fondatore, Adam Neumann.
Con la promessa di “creare gli uffici del futuro”, fino al 2019 WeWork era riuscita nell’incredibile impresa di raccogliere oltre 20 miliardi di dollari di investimenti e raggiungere una valutazione di mercato di 47 miliardi di dollari – circa il PIL della Slovenia, per capirci. Se non che, quando decise di entrare in borsa nell’agosto di quell’anno e dovette mostrare i conti, venne fuori che solo nel 2018 WeWork aveva perso 2 miliardi di dollari. L’offerta pubblica fu un disastro e il suo fondatore, Neumann, venne licenziato, ma con una buona uscita da 1,7 miliardi di dollari e uno stipendio da consulente da 46 milioni di dollari l’anno.
Ma questi, si dirà, sono gli eccessi americani: com’è la situazione in Italia? Uguale, solo in tono (molto) minore. Nell’Italia pre-pandemia del 2018, delle 100 migliori StartUp solo 47 risultavano attive da più di tre anni, e queste erano comunque in perdita media di quasi mezzo milione di euro. Solo 14 risultavano in utile, e solo due ne registravano uno sopra il mezzo milione di euro. Quelle che andavano meglio erano in settori tradizionali come la consulenza fiscale, mentre quelle digitali andavano peggio di tutti. E tutto questo nonostante cospicui incentivi pubblici nel settore start-up e una normativa fatta su misura.
A raccogliere questi dati è stato Vincenzo Luise, professore in digital sociology all’Università Statale di Milano, autore del libro “Le forme dell’innovazione nell’ideologia californiana”. «Le start-up – racconta – oggi non sono, come molti credono, aziende altamente innovative orientate alla creazione di business sostenibili. Sono in realtà oggetti di investimento finanziario: il loro vero obiettivo è incrementare il valore delle quote di chi ci ha investito e poi generare un ritorno con una “exit”, cioè l’acquisto da parte di un terzo. Questo modello di finanziamento di basa sull’idea futura del successo economico. Un futuro che, però, sembra non realizzarsi mai».
Sì perché questa è la massima ambizione per una start-up oggi: non diventare il prossimo unicorno che stravolge il mercato, ma farsi acquistare da una grande impresa. I più furbi cercano di farlo investendo moltissimo in reputazione e branding, e quindi poco in vera innovazione. «Parlando con gli startupper italiani – racconta Luise – colpisce il fatto che non pensano di fare della vera innovazione: sanno che non possono competere con I grandi big tech che ormai hanno monopolizzato diversi settori dell’economia digitale. I loro obiettivi sono cambiati: non più essere il nuovo Zuckerberg, ma creare piccole società che possano rendersi visibili con l’obiettivo di essere acquisite da una grande azienda; ma non per vivere poi di rendita, per ma andare a lavorare per loro! La start-up, insomma, è diventata un’alternativa al CV».
D’altronde, anche il sistema degli intermediari non se la passa meglio. Incubatori, coworking, acceleratori oggi in Italia mostrano conti in rosso o utili bassissimi, e sopravvivono quasi solo grazie a fondi statali e europei – significativo, se si pensa che il loro lavoro dovrebbe essere quello di insegnare come rendere profittevole un’azienda. D’altronde, anche culturalmente non siamo un Paese abituato all’investimento di rischio: i capitali una volta investiti in mercati solidi e a basso rendimento come l’immobiliare cercano oggi altre rendite, e le cercano anche nelle startup – visto che, peraltro, fa immagine. Ciò fa sì che nessuno oggi in Italia investa nella fase iniziale di una start-up, quando il rischio c’è, ma solo quando fattura e sta già in piedi da sola.
Agli startupper italiani oggi si consiglia di ricorrere a “family, friends and fools”: letteralmente, attingere dal capitale familiare o da quello di qualche “pazzo” occasionale per trovare i fondi per partire e poi nel caso ripassare. Questo comporta che solo chi è già in una posizione agiata può permettersi di fare lo startupper, mentre tanti con buone idee e talento magari non riescono nemmeno a partire o vengono snobbati persino se hanno buoni ritorni, anche economici. «In alcuni casi – racconta ancora Luise – mi è stato detto di start-up con bei risultati anche economici fatte morire dagli investitori perché non aderenti ai temi del momento o a una narrazione di crescita esponenziale».
Una narrazione che deve essere difesa a ogni costo e, l’ultimo asso nella manica dello start-up system per farlo è stato il modello “VCtoC”, ovvero i Venture Capital saltano gli intermediari e investono direttamente in nuove start-up attive sul tema del momento. Con i capitali così raccolti, le start-up entrano sul mercato con prezzi bassissimi, in perdita, facendo un minimo di margine quasi solo grazie a fattori come l’elusione fiscale o la forza lavoro a bassissimo costo, ma intanto prendendo quote di mercato e fiaccando la concorrenza – è il caso, per esempio, di alcune start-up di food delivery. Intanto, i Venture Capital ritardano sempre più l’entrata in borsa, in modo da non dover mostrare pubblicamente i conti e non fare la fine di WeWork. Ma si tratta di una mossa disperata, utile solo a guadagnare un po’ di tempo nella speranza che una nuova idea come quella della Lean startup dia una terza vita al settore.
Ma quindi, perché ha avuto e ha ancora successo il modello delle start-up? In parte c’entrano fattori come l’ampia disponibilità e quindi il basso costo di una forza lavoro giovane e dalle competenze elevate, la forte riduzione dei costi di avvio di un’impresa, e il desiderio delle grandi aziende di esternalizzare i costi di ricerca e sviluppo. Ma la vera forza dello start-up system è la sua narrazione. Lo stesso Neumann lo disse con disarmante chiarezza in un’intervista: «Nessuno investe in una azienda, anche se vale 20 miliardi. La valutazione di WeWork è basata molto di più sulla nostra energia e spiritualità che sulla moltiplicazione delle entrate».
La narrazione delle start-up ha sfondato facendo leva sulla generazione dei “millennial”: giovani cresciuti in un brodo di cultura tecno-ottimista che, nonostante le alte competenze, facevano – e fanno – fatica a collocarsi nel mondo del lavoro. Inoltre, il modello delle start-up ha permesso di dare una veste nuova al capitalismo, che lo rendesse più attraente nascondendo le sue profonde iniquità economiche e generazionali, e che desse la speranza di una specie di “rivoluzione educata dal basso”, per “cambiare il mondo grazie all’innovazione e al merito”.
Il modello startup ha quindi dato a una generazione un lavoro – anche se pagato poco o per nulla; anzi –, un’identità e un sogno in cui credere, e una nuova narrazione attraente al capitalismo. Ma non solo. Cavalcando l’onda montante dell’inevitabilismo tecnologico, e sfruttando gli hype del momento – dai droni all’intelligenza artificiale; dalla stampa 3D alla blockchain – è riuscito a coinvolgere nella sua narrazione enormi capitali pubblici e privati, e a creare un “ecosistema” in cui peraltro “riciclare” anche lavoratori senior in uscita da aziende in difficoltà, con profili da manager e anch’essi in cerca di lavoro e identità.
In Italia la pandemia ha certamente colpito anche questo settore, ma con oltre un miliardo di euro statali affidati a Cassa Depositi e Prestiti, di certo la linfa per un po’ non mancherà. Ma, lo abbiamo visto, non sono i soldi il punto per lo start-up system. Il guaio vero è che la sua narrazione sta perdendo potenza, poiché i giovani di oggi guardano alla tecnologia come qualcosa di naturale, scevro da quell’aspetto “magico” che ancora vi vedono le generazioni precedenti, e perché sono meno interessati all’imprenditorialità e al successo economico. Hanno invece forti interessi politici, sociali ed ecologici, e infatti ora lo start-up system sta tutto virando sull’ “Impact first”, ovvero l’impatto sociale come valore primario, ma ci sono leciti dubbi che i nuovi giovani si lascino incantare.
Insomma, il modello start-up ha mangiato sé stesso, creando dei colossi che ammazzano la concorrenza e una cultura che scoraggia la vera innovazione. Invece di tante aziende profittevoli e innovative, come si proponeva di fare, ha creato un pugno di giganti dai piedi d’argilla e decine di migliaia di micro-imprese fallite. E invece di un modello che promuove il merito e l’innovazione, si è trasformato in un sistema con possibilità solo per chi ha capitali propri da investire e che produce pletore di micro-imprese che fanno tutte più o meno la stessa cosa, facendo a gara a chi si fa notare di più. Certo, qualche innovazione positiva c’è stata, così come qualche caso di successo, ma sarebbe un errore pensare che sia una strada da intraprendere, specie come Paese.
Se il Governo Conte con i “ristori” aveva avuto un approccio “spray and pray” come nella prima fase dell’ideologia californiana – sosteniamo tutti e che Dio ce la mandi buona –, il Governo Draghi potrebbe essere tentato di adottare il metodo Lean, per dare a migliaia di micro-imprenditori che hanno dovuto chiudere per la pandemia una seconda opportunità e “vinca il migliore”. Può aver senso. Ma, francamente, si può ben immaginare quali possono essere gli esiti di dare a un ex-ristoratore 50enne che ha chiuso la serranda o a una 40enne che ha dovuto chiudere il suo alberghetto uno spazio in un coworking o un corso di app-design, dove magari si magnificano le imprese di Deliveroo e AirBnB, che già prima del Coronavirus gli avevano tolto clienti e margini di guadagno.

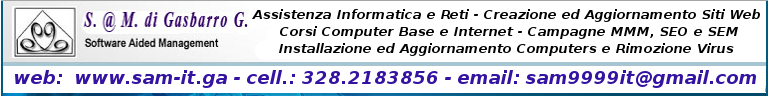


Lascia un commento