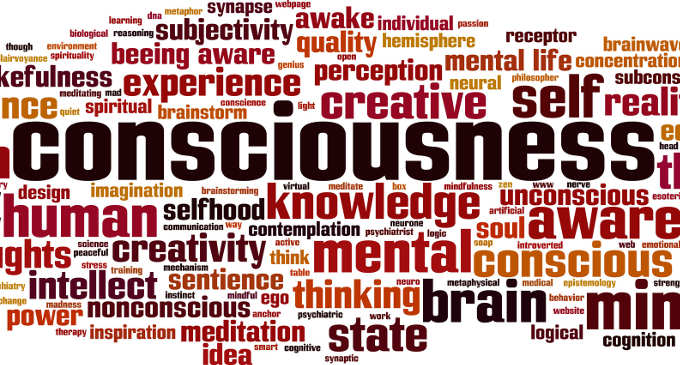
La coscienza è da sempre oggetto di studio in molteplici ambiti, dalla filosofia alla psicologia, fino alle neuroscienze e alla scienza cognitiva.
Fascino e controversie, sull’onda di una ricerca che da secoli divide e sollecita continuamente nuove domande: la coscienza è da sempre oggetto di studio in molteplici ambiti, dalla filosofia alla psicologia, fino alle neuroscienze e alla scienza cognitiva.
La coscienza è l’ultima e la più tardiva evoluzione della vita organica,
e di conseguenza è ciò che vi è di meno compiuto e più fragile
F. Nietzsche
Fascino e controversie, sull’onda di una ricerca che da secoli divide e sollecita continuamente nuove domande: la coscienza è da sempre oggetto di studio in molteplici ambiti, dalla filosofia alla psicologia, fino alle neuroscienze e alla scienza cognitiva. Per secoli l’uomo ha cercato di trovare un significato a quella parte di sé più peculiare e a tratti impenetrabile, per secoli esclusa dalle speculazioni scientifiche e infine accolta e studiata con lenti oggi nuove.
Il concetto di coscienza, spesso riferito a processi e contenuti mentali molto diversi tra loro, allude quindi a realtà apparentemente sfuggenti e difficilmente individuabili. Quando poi si guarda all’altro lato della sua complessità, ovvero la non consapevolezza o, per alcuni, l’inconscio, le controversie aumentano, così come il fascino che tali processi esercitano su studiosi e scienziati da oltre un secolo.
La coscienza tra filosofia e scienza: breve quadro introduttivo
In ambito filosofico il dualismo cartesiano mente/corpo ha relegato a lungo il mentale a una dimensione ontologica, impedendo che divenisse oggetto di studio da parte delle scienze naturali.
L’idea secondo cui l’uomo sarebbe costituito da due sostanze ontologicamente distinte, la rex extensa, ovvero la materia, dotata di estensione spaziale e di cui fanno parte i corpi (quindi anche il cervello) e la rex cogitans, sostanza inestesa dotata dell’attributo del pensiero, ha di fatto rallentato, se non impedito, lo studio della coscienza come fenomeno riducibile a eventi fisici. Nell’opera di Cartesio, infatti, la coscienza non può nascere dalla materia perché rex extensa e rex cogitans, diverse nella sostanza e regolate da principi differenti, non possono essere ricondotte l’una all’altra, né possono essere spiegate l’una con l’altra. Di conseguenza, nella visione cartesiana e nelle varianti neo-cartesiane, gli stati coscienti della mente non corrispondono agli stati fisici del cervello. I contenuti di coscienza non sono quindi esplorabili con gli strumenti propri delle scienze naturali, ma solo seguendo la metodologia soggettiva dello “sguardo interiore” (cifra interpretativa che di fatto decreta l’impossibilità dello studio scientifico della coscienza).
Le correnti di pensiero filosofico che delegittimano lo studio della coscienza rifiutandone le prerogative causali (epifenomenismo) o addirittura negandone l’esistenza (eliminativismo) contestano poi qualsiasi validità degli studi empirici sull’argomento (Smith-Chuurchland, 1986). Nel materialismo eliminativista il concetto di coscienza viene rifiutato perché le nostre esperienze fenomeniche (dette anche qualia) non si riferirebbero a una realtà esterna, valutabile oggettivamente, ma sarebbero il prodotto illusorio di resoconti soggettivi (Dennet, 1991). Secondo questa corrente di pensiero, quindi, la ricerca empirica non troverà mai le basi neurali dell’esperienza soggettiva perché di fatto l’esperienza soggettiva non si riferisce a nessuna realtà sostanziale.
Quando all’inzio del ‘900 il mentalismo cartesiano e il dominio della coscienza si iniziarono a scontrare con fenomeni inconsci quali la grande isteria convulsiva, la fuga dissociativa, l’amnesia psicogena e il disturbo di personalità multiple (che sembravano esibire una natura mentale ma al tempo stesso trascendevano la sfera della consapevolezza), lo sconcerto di filosofi, psicologi e neuroscienziati si delineò con forza. Al fine di riconciliare l’esistenza di fenomeni mentali apparentemente inconsci con una visione coscienzialistica della mente, si misero a punto due strategie (Livingstone-Smith, 1999): alcuni studiosi negarono che si avesse a che fare con fenomeni realmente insconsci, definendoli piuttosto come casi in cui si era verificata una dissociazione o scissione della coscienza (teorie dissociazioniste), mentre altri negarono che i fenomeni in questione fossero autenticamente mentali, descrivendoli come disposizioni neurofisiologiche (teorie disposizioniste).
Anche in epoca moderna lo studio della coscienza non è stato sempre accettato e condiviso dagli studiosi di campi comunque coinvolti nelle ricerche sulla psiche. In ambito psicologico, l’approccio ancora soggettivo del metodo introspettivo proposto dalla Scuola di Wundt (1896) è stato bandito infatti dalla ricerca psicologica con l’avvento del Comportamentismo che, spinto da una necessità estrema di oggettivizzazione degli studi, respinge l’indagine privata di contenuti di coscienzaperché non documentabile e quantificabile con le tecniche proprie degli studi di laboratorio.
Coscienza e neuropsicologia
Tuttavia, anche se bandito dagli studi psicologici per un lungo periodo del secolo scorso, il problema di cosa sia la coscienza ha finito per imporsi in ambito neuropsicologico, in cui la ricerca attenta e sistematica dei disturbi cognitivi provocati dalle lesioni cerebrali ha cominciato a suscitare interesse.
A partire dagli anni ’80 del XX secolo la coscienza ha così conquistato una propria dignità scientifica, in particolare all’interno delle neuroscienze cognitive e della neuropsicologia. In particolare, in questi anni incominciano ad essere studiati e pubblicati casi di pazienti con lesioni cerebrali che presentano dei disturbi di consapevolezza motoria o spaziale apparentemente inspiegabili in base alla nozione di coscienza adottata dal senso comune. Si tratta di soggetti che, nonostante abbiano perso la capacità di movimento di una metà del corpo (emiplegia) o la capacità di percepire e concepire una metà dello spazio esterno (negligenza spaziale), si comportano come se non ne fossero consapevoli (anosognosia) (Berti et al., 2014). Nel corso dei decenni sono state così portate alla luce numerose patologie della coscienza, quali il blindsight o visione cieca (Weiskrantz, 1986), la emisomatoagnosia (Bisiach, 1999), la sindrome della mano aliena (Biran e Chatterjee, 2004), l’embodiment (Garbarini et al., 2013) e la somatoparafrenia.
Ciò che accomuna queste sindromi neuropsicologiche è il fatto di mostrare l’esistenza di disturbi della sfera della coscienza circoscritti all’interno di specifiche dimensioni cognitive (per esempio quella visiva, motoria o corporea), con network neuronali dedicati, rivelando che il concetto di coscienza alla base del sé non è unitario, ma multicomponenziale o modulare.
Inizia a emergere così l’idea, in contrasto col senso comune che reputa la coscienza come dotata di una struttura unitaria e indivisibile, di molteplici coscienze distribuite ed emergenti ciascuna all’interno di una diversa funzione cognitiva: una lesione cerebrale circoscritta può quindi danneggiare la consapevolezza relativa a un certo processo senso-motorio, senza intaccare lacoscienza per altri processi paralleli e concomitanti. Il senso di sé potrebbe dunque configurarsi proprio come il risultato dell’integrazione di queste diverse “coscienze parziali”.
Una sensazione così radicata della nostra autocoscienza, come il fatto che il nostro corpo è uno e sempre lo stesso, che si muove intenzionalmente in forza di questo senso di unicità e che abita uno spazio soggettivamente percepito come unico, in realtà non ha quindi una struttura unitaria e indivisibile, ma è il risultato di rappresentazioni multiple a livello spaziale e senso-motorio, che possono essere alterate in modo autonomo per effetto di lesioni cerebrali circoscritte.
Ecco che dunque i paradigmi della scienza cognitiva dei processi di elaborazione dell’informazione risultano particolarmente indicati per mettere in luce un modello multicomponenziale della mente, che ben si adatta ad essere lesionato in modo circoscritto. Su questo tema si interrogano in un articolo Vittorio Gallese e Francesca Ferri (2014): gli autori discutono la possibilità che alla base dei disturbi dissociativi schizofrenici ci possa essere una alterazione del senso di sé corporeo e agente (predisposizione all’azione), una forma di distacco del sé dalle sue basi corporee somatosensoriali e motorie che porterebbe anche all’impossibilità dell’interazione sociale. Questa ipotesi sarebbe corroborata anche dai dati di diverse ricerche che dimostrano una alterazione delle rappresentazioni somatosensoriali (deficit di riconoscimento di proprie parti del corpo), motorie (deficit nel discriminare se movimenti osservati sono propri o altrui) e dolorifiche (riduzione della percezione dolorifica) nei pazienti schizofrenici.
Un’architettura neurocomputazionale compatibile col modello modulare della coscienza è quella del Global Workspace Theory – GWT – (Baars, 1997), che introduce anche il concetto di inconscio. In questa architettura il ruolo della coscienza è quello di facilitare lo scambio di informazioni traprocessi cognitivi inconsci, specializzati e paralleli. Più recentemente questa teoria è entrata in simbiosi con la neuroscienza cognitiva soprattutto per merito di Dehaene e collaboratori (Dehaene e Naccache, 2011; Deahene e Changeux, 2004; Gaillard et al., 2009). Secondo questi ricercatori, nel cervello sono presenti due spazi computazionali, ognuno caratterizzato da una diversa trama di connettività.
Il primo spazio è costituito da sottosistemi di elaborazione ipotizzati dalla GWT, ognuno dei quali è specializzato nel trattare un particolare tipo di informazione (per esempio, nella corteccia occipito-temporale l’elaborazione del colore ha luogo in V4, l’elaborazione del movimento in MT/V5, l’elaborazione dei volti nell’area fusiforme delle facce…). L’operare di questi elaboratori modulari si avvale di connessioni locali limitate di medio raggio. Il secondo spazio è la spazio di lavoro globale neuronale (per cui ora si parla di una Global Neuronal Workspace Theory, GNWT): esso è costituito da neuroni distribuiti, tenuti assieme da connessioni di lunga distanza, particolarmente densi nell’area prefrontale, nel cingolato e nelle regioni parietali. L’ingresso dell’informazione in questo spazio di lavoro sarebbe il correlato neuronale dell’accesso alla coscienza.
Questo modello ha ricevuto una serie di importanti conferme sperimentali. In uno studio fRMI, Dehaene et al. (2006) hanno utilizzato il paradigma del priming di mascheramento per porre a confronto l’elaborazione lessicale inconscia con quella cosciente. Una parola veniva proiettata su uno schermo per poche decine di millisecondi, subito seguita da un’altra immagine (la maschera), che impediva al soggetto di percepire la parola a livello conscio. In genere, la parola diviene cosciente quando l’intervallo tra essa e la maschera è di circa 50 ms. I risultati hanno mostrato che le parole mascherate (inconsce) hanno indotto un’attività locale nelle parti della corteccia visiva deputate al riconoscimento di parole, mentre le parole visibili (coscienti) hanno generato un’intensa attività anche nei lobi parietale e frontale. Dunque, in accordo alla GNWT, l’elaborazione cosciente di informazioni recluta risorse cerebrali fortemente distribuite, mentre l’elaborazione inconscia è più localizzata.
Inconscio cognitivo (1): processi di elaborazione non consapevoli
Ad oggi le neuroscienze hanno dimostrato pertanto anche l’esistenza di numerosi processi neurali responsabili di stati non accessibili alla coscienza: è questa una prima concettualizzazione dell’”inconscio cognitivo”, ovvero quella parte del funzionamento mentale che è inconscia non perché è stata rimossa (come concettualizzato dalla Teoria Psicoanalitica), ma perché non è mai stata conosciuta, e quindi non sarà né potrà mai essere ricordata. Fanno parte di questo inconscio tutti quei processi cognitivi che avvengono in modo “covert” e non raggiungono l’elaborazione corticale consapevole.
Berlin (2011), in una ricca review che indaga il rapporto tra inconscio e relative basi neurali, descrive una grande varietà di stati inconsci riscontrabili a livello cognitivo, tra cui:
- Percezione subliminale, in cui lo stimolo è al di sotto della soglia e quindi troppo debole per produrre l’esperienza cosciente;
- Mascheramento, in cui anche un forte stimolo può inizialmente eccitare le aree visive ma l’interferenza in una fase successiva di elaborazione impedisce l’esperienza cosciente;
- Visione cieca, in cui le vie sottocorticali possono portare alla rappresentazione inconscia di uno stimolo;
- Neglect;
- Rivalità binoculare, in cui uno stimolo presentato ad un occhio inibisce il processamento di uno stimolo presentato all’altro occhio;
- Crowding, in cui i campi di integrazione spaziale nella periferia sono troppo grandi per isolare un singolo oggetto, e così rappresentazioni di proprietà di oggetti diversi interferiscono uno con l’altro (Pelli e Tillman, 2008).
Inoltre, i dati di ricerca mostrano che anche processi motivazionali ed affettivi possono verificarsi al di fuori della consapevolezza, andando a confermare alcune intuizioni di Freud ed evidenziando che l’attività mentale è radicata in sistemi motivazionali ed emozionali filogeneticamente antichi, capaci di influenzare la sviluppo della mente (LeDoux, 1998a; Panksepp, 1988; Pfaff, 1999) e di operare al di fuori della piena consapevolezza.
Una recente review (Custers e Aarts, 2010) raccoglie infatti gli studi che mostrano come anche obiettivi e motivazioni possono operare al di fuori della coscienza (un fenomeno che chiamano “unconscious will”). I risultati evidenziano che in certe circostanze le azioni possono essere iniziate senza che il soggetto sia consapevole dell’obiettivo finale.
Studi sugli aspetti inconsapevoli delle emozioni dimostrano poi che le persone possono sperimentare stati emotivi e agire di conseguenza senza esserne consapevoli (possono quindi provare qualcosa senza sapere che la stanno provando). I dati sperimentali dimostrano infatti che il processamento emotivo ha inizio al di fuori della consapevolezza (Balconi e Lucchiari, 2008; Bunce et al., 1999; LeDoux, 1998a; Phelps et al., 2000; Wiens, 2006). Evidenze circa l’esistenza di unapercezione inconscia di volti mascherati sono emerse da studi che si sono avvalsi di report soggettivi (Esteves, Parra, Dimberg, & Öhman, 1994), risposte autonomiche (Morris, Buchel, & Dolan, 2001a) e brain imaging (Whalen et al., 1998). In alcuni studi, ad esempio, i soggetti mostravano una conduttanza cutanea maggiore in risposta a volti spaventosi mascherati (Esteves et al., 1994) e i potenziali evocati dimostravano l’avvenuto processamento di stimoli subliminali (volti spaventosi), sostenendo così l’esistenza di processamenti emotivi al di fuori della consapevolezza (Kiss & Eimer, 2008).
Si ritiene che queste “emozioni inconsce” siano mediate da un circuito sottocorticale che include il collicolo superiore, il pulvinar e l’amigdala (Berman & Wurtz, 2010; Diamond & Hall, 1969; Lyon, Nassi, & Callaway, 2010). Si è osservato inoltre che immagini a valenza attivante (volti spaventati o arrabbiati) determinano un incremento dell’attività dell’amigdala anche quando sono mascherate da altri stimoli, agendo dunque al di fuori della consapevolezza (Morris, Ohman e Dolan, 1998; Whalen et al., 1998).
Le emozioni possono quindi essere anche precognitive: la “rivoluzione emotiva” che si è insinuata nel cognitivismo standard soprattutto in risposta alle difficoltà di trattamento dei “pazienti difficili” (Roth e Fonagy, 2004) ha preso le mosse proprio dalla messa in crisi del grande cardine su cui il cognitivismo nato da Beck ed Ellis si imperniava, ovvero il dominio assoluto delle cognizioni sulle emozioni.
E’ ormai dunque dimostrato che ci siano aspetti delle nostre reazioni emotive non chiari allacoscienza. Inoltre, ricordi e temi di vita dolenti possono nascondersi oltre la soglia della consapevolezza e stimoli contestuali del tempo presente possono farli rivivere. Questa è l’idea chiave di Conway e collaboratori (2004), ricercatori esperti nella memoria autobiografica, e della loro Self-Memory System Theory (Conway&Pleydell-Pearce, 2000). Questa teoria descrive il sistema di controllo esecutivo centrale non solo come attivatore di strategie cognitive, ma anche come inibitore dell’accesso di informazioni autobiografiche nella coscienza, in quanto pericolose e dolorose. Il sistema associativo, con cui leghiamo stimoli nella nostra memoria a lungo termine (o conoscenza autobiografica) entra poi in gioco in modo significativo: i ricordi o gli stimoli che nella rete associativa si pongono in una posizione di vicinanza al tema dolente vengono marchiati essi stessi come pericolosi e innescano una risposta di inibizione e di evitamento mentale. La Self-Memory System Theory offre così un ponte di discussione tra approcci dinamici e cognitivi su temi di grande importanza clinica, quali l’attività mentale ai limiti della consapevolezza e i meccanismi di difesa. Per alcuni ricercatori, inoltre, questa teoria rappresenta la spiegazione di fondo dell’efficacia di una terapia ad oggi di grande successo: l’Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) (Gunter e Bodner, 2009).
Inconscio cognitivo (2): memorie e rappresentazioni mentali implicite
Alla luce delle numerose evidenze e considerando anche la concettualizzazione di inconscio emergente dalla teoria psicoanalitica (e le successive revisioni in ambito psicodinamico), è possibile sostenere l’esistenza di “molti inconsci”, ciascuno dei quali fa riferimento a processi e cornici teorico-concettuali differenti.
L’inconscio cognitivo, in particolare, non si configura unicamente come un insieme di processi covert e attivazioni neurali, ma è concepito anche come un mondo di rappresentazioni mentali implicite o tacite (cioè non consapevoli) che, se disfunzionali, vanno modificate in psicoterapia. Tali credenze irrazionali sono “transferali” nel senso che si sono create nell’infanzia per dei motivi che nell’età adulta non sussistono più (e per questo il paziente deve imparare a sostituirle con credenze più funzionali). Si può quindi dire che l’inconscio cognitivo sia quella parte di noi anche denominabile “memoria procedurale” o “elaborazione parallela distribuita”.
Più precisamente, a partire dal momento in cui, nell’intersoggettività, iniziamo a sviluppare le nostre capacità linguistiche, la conoscenza che abbiamo di noi stessi e del mondo si ripartisce in due categorie. La prima, che non utilizza il linguaggio, è stata definita implicita, procedurale, tacita o non dichiarativa (“saper come”), mentre la seconda, fondata sul linguaggio, è detta dichiarativa o semantica o esplicita (“sapere che”). Il “sapere come”, base dell’inconscio cognitivo, è costituito da schemi senso-motori ed emozionali che prescindono dal linguaggio.
I processi inconsci operano attraverso processi simultanei, a differenza di quanto avviene invece nella coscienza, che lavora attraverso processi seriali. La coscienza opera quindi una selezione tra le tante informazioni presenti nell’inconscio e questo è il motivo per cui quello che diventa conscio è sempre una parte molto ridotta e forse anche distorta della complessità delle elaborazioni inconsce parallele. Ciò che esce dall’inconscio non è quindi mai uguale a quanto vi era contenuto: i due linguaggi non sono facilmente traducibili l’uno nell’altro, poiché si tratta di codici cognitivi diversi nella loro natura (in quanto alcune rappresentazioni inconsce non sono neppure esprimibili a parole, si pensi ad esempio alla memoria procedurale che regola il movimento). E’ in questo che l’inconscio cognitivo si differenzia nettamente da quello dinamico, poiché quest’ultimo prevede una certa traducibilità dei contenuti mentali rimossi, mentre l’inconscio cognitivo si configura più come una modalità di immagazzinamento nella memoria implicita, poco o per nulla soggetta ad elaborazione verbale.
Pertanto, nella prospettiva cognitiva, ed in particolare in quella cognitivo-evoluzionista, è di gran lunga più interessante studiare i modi in cui alcune attività mentali non riescono ad acquisire la qualità della coscienza anche laddove sarebbe importante che ciò avvenisse, piuttosto che indagare come un contenuto mentale possa essere rimosso nell’inconscio per difesa dall’angoscia (Liotti, 1996a). L’importanza della trasformazione di attività mentali non coscienti in attività coscienti sta soprattutto nel loro divenire comunicabili attraverso il linguaggio, e dunque modulabili e condivisi in una dimensione intersoggettiva (Liotti, 2001). Fra i processi mentali che dovrebbero acquisire la dimensione della coscienza per divenire modulabili, emozioni e affetti sono certamente, anche da un punto di vista clinico, i principali.
Questo inconscio cognitivo procedurale riguarda anche i rapporti interpersonali, ad esempio certi aspetti degli stili di attaccamento. Queste modalità relazionali apprese nell’infanzia, permangono nell’adulto e regolano buona parte della vita quotidiana e del funzionamento affettivo. Alcune emozioni nascono quindi da vulnerabilità sviluppatesi durante la storia evolutiva dell’individuo (sotto forma di genitori dannosi ed esperienze traumatiche), fuori cioè dalla coscienza (Caselli, 2012). Questa maggiore consapevolezza ha messo in scacco sia il cardine cognitivista della maggiore importanza del funzionamento attuale su quello storico-evolutivo, sia l’ideale psicoanalitico di poter incidere terapeuticamente su certi comportamenti, soprattutto in pazienti gravi, col solo strumento dell’interpretazione verbale.
Quando infatti il cognitivismo standard inizia a confrontarsi con il trattamento di pazienti complessi, con disturbi di personalità e gravi deficit sul piano relazionale e metacognitivo, le tecniche fino a quel momento di grande efficacia con pazienti con disturbi d’ansia e depressione hanno incominciato a scricchiolare e si è reso necessario un ampliamento del paradigma, che andasse ad includere anche aspetti apparentemente indipendenti dalla consapevolezza.
La svolta relazionale del cognitivismo in Italia è stata profondamente influenzata dalla Teoria dell’attaccamento di Bowlby. In particolare, l’orientamento cognitivo-evoluzionista ha trovato in questa teoria una base concettuale per spiegare gran parte del funzionamento generale della mente e della psicopatologia, tenendo conto sia degli aspetti più vicini al cognitivismo standard, sia di quegli elementi relazionali e impliciti che la avvicinano a tratti alla matrice psicoanalitica.
Coscienza e inconscio nella prospettiva cognitivo-evoluzionista
L’idea unificante essenziale è che l’uomo possieda, fin dalla nascita, una serie di disposizioni o tendenze innate, definite Sistemi Motivazionali, che non richiedono la coscienza per operare in quanto evolute prima della comparsa della coscienza umana ed esistenti ancora oggi in specie animali prive di autocoscienza. Esse configurano quindi il fondamento innato di una attività mentale inconscia. Le disposizioni innate alla relazione sociale, in particolare, divengono coscienti in forma di esperienze emozionali (il che è congruente con un paradigma di regolazione delle emozioni, e non con quello pulsionale). L’uomo ha dunque diverse disposizioni innate alla relazione, da cui emergono diversi Sistemi Motivazionali Interpersonali (SMI) a base innata che operano al di fuori della coscienza. Essi organizzano, una volta attivati, il comportamento sociale e l’esperienza emozionale e rappresentazionale di sè-con-l’altro. Le emozioni sono le prime fasi delle operazioni mentali organizzate dagli SMI che possono conseguire la qualità dell’esperienza cosciente. La conoscenza che si sviluppa a partire da tali disposizioni innate alla relazione è di tipo implicito e non richiede, per il suo funzionamento, né la coscienza né l’autocoscienza.
Messaggio pubblicitarioLe emozioni appaiono nell’esperienza soggettiva prevalentemente come fasi delle operazioni degli SMI; le prime operazioni, riguardanti la regolazione del comportamento interpersonale, sono avvolte nel silenzio del corpo e sono totalmente estranee allacoscienza. Operazioni successive degli SMI raggiungono poi la coscienza in forma di emozioni. Il completamento cognitivo del processo emozionale porta al tipo di esperienza cosciente che Damasio (1999) chiama conoscenza del sentimento. Gli SMI sono pertanto attivi ed operano prevalentemente al di fuori della coscienza. Le emozioni, dunque, emergono nella relazione e rimandano ad essa: la coscienza appare quindi come un processo intrinsecamente interpersonale.
Nel modello cognitivo-evoluzionista si suppone che la formazione dei significati personali patogeni discenda dalle memorie implicite formate durante le esperienze di attaccamento precoci e organizzate nei Modelli Operativi Interni (MOI), strutture di conoscenza che da un lato rappresentano l’esperienza di sé-con-l’altro effettuata attraverso ripetute interazioni di attaccamento, dall’altro attribuiscono valore e significato alle emozioni di attaccamento percepite in sé e negli altri.
La memoria delle percezioni di sé-con-l’altro che si susseguono nel tempo durante il primo anno di vita è dunque tacita, non dichiarativa, procedurale, e mette capo alla coscienza nucleare (Damasio, 1999) o primaria (Edelman, 1989), il cui fondamento è di natura emozionale e non implica il linguaggio. La conoscenza relativa alla mente propria e altrui può poi diventare dichiarativa (semantica ed episodica), e mette capo alla coscienza di ordine superiore, che si avvale invece di processi linguistici.
In particolare, la memoria implicita del bambino a partire dai primi giorni di vita sintetizza progressivamente le sequenze interattive in cui la figura di attaccamento risponde alle sue emozioni di attaccamento, organizzandole in rappresentazioni generalizzate delle interazioni e in Modelli Operativi Interni. Quando i MOI relativi all’attaccamento, contenuti nella memoria implicita, si confrontano con le nascenti capacità linguistiche del bambino, iniziano a prendere forma strutture semantiche da cui poi derivano i grandi temi narrativi che caratterizzano i diversi pattern di attaccamento. Tali nuclei di significato, intorno ai quali ruotano i processi organizzativi della conoscenza di sé, possono quindi non essere coscienti.
La dissociazione fra conoscenza semantica e conoscenza episodica, che si sviluppa all’interno della relazione di attaccamento, è alla base degli esiti psicopatologici. Inoltre, il tema semantico intorno a cui si costruisce la conoscenza di sé-con-l’altro predispone a disturbi emozionali in quanto non permette la conoscenza adeguata del significato e del valore (e quindi la regolazione) di alcune classi di emozioni fondamentali, prevalentemente riferite al Sistema Motivazionale dell’Attaccamento. Se ad esempio nessuno risponde (o risponde ma in modo inadeguato) ai segnali emozionali espressi dal bambino nella relazione di attaccamento, questi non potrà che rappresentare, nella conoscenza implicita di sé-con-l’altro, le proprie emozioni come radicalmente inutili, inefficaci o pericolose per il mantenimento della relazione; inoltre non potrà costituire alcuna rappresentazione delle emozioni dell’altro, in quanto l’altro è assente o ambivalente.
Se nel paradigma psicoanalitico sono le difese inconsce ad ostacolare la presa di coscienza delle emozioni, nella concettualizzazione cognitivo-evoluzionista sono dunque l’intersoggettività e l’interazione tra emozioni e cognizioni a giocare un ruolo chiave: le difese appaiono infatti più indirizzate a gestire le conseguenze di drammatiche e infelici esperienze reali di attaccamento. Così ad esempio, nell’attaccamento insicuro evitante, il MOI del bambino contiene una rappresentazione di sé come fastidioso se richiedente attenzioni e cure e dell’altro come indisponibile. Pertanto, ricordi episodici negativi nell’interazione con i genitori, possono essere esclusi dalla coscienza perché occupata da rappresentazioni semantiche idealizzate dei genitori stessi. L’interdizione del ricordo è così dovuta a pressioni interpersonali più che alla necessità della coscienza di proteggersi dall’angoscia generate da pulsioni inaccettabili.
Secondo questa tesi, sviluppata dallo stesso Bowlby, i genitori imponevano al bambino, attraverso le loro parole e sotto la minaccia implicita di abbandono affettivo qualora non le avesse accettate, di attribuire un significato positivo ad un’esperienza che in se stessa era stata emotivamente negativa. L’idealizzazione dei genitori, dunque, non appare come una difesa da pulsioni aggressive verso di loro, ma come effetto del gioco congiunto di pressioni interpersonali e della disposizione innata del bambino a cercare conforto nelle figure di attaccamento. Se ricordi episodici negativi vengono esclusi dalla coscienza perché questa è occupata ad elaborare significati idealizzanti e irrealistici della relazione con le figure di attaccamento, questi ricordi esclusi costituiscono esempi dell’inconscio cognitivo più che del classico inconscio psicoanalitico (Liotti, 2001).
Anche nella Teoria dell’attaccamento, dunque, l’inconscio è ampiamente concepito come insieme di rappresentazioni e memorie implicite delle relazioni di attaccamento, e si avvicina molto di più all’inconscio cognitivo, inteso per l’appunto come processi e conoscenze implicite, piuttosto che a quello psicoanalitico, topico o dinamico (Laplanche e Pontalis, 1993; Ellenberger, 1970; Eagle, 1987). L’incontro con la Teoria dell’attaccamento ha determinato dunque il rinnovato interesse dei cognitivisti per le attività mentali inconsce e per la dimensione relazionale dello sviluppo normale e patologico (Liotti, 2011; Semerari, 2000). La Teoria dell’Attaccamento ha così permesso ai cognitivisti di comprendere il ruolo centrale, nella formazione della personalità e nella genesi dei disturbi emotivi, delle strutture di memoria inconscia (implicita) costruite nelle esperienze di attaccamento.
Tale prospettiva ha permesso quindi di allargare il lavoro del terapeuta cognitivista dall’attenzione esclusiva su processi e contenuti cognitivi espliciti, ritenuti i soli responsabili dei disturbi emotivi, all’ampio e complesso fronte delle strutture e dei contenuti impliciti costruiti nelle prime relazioni intersoggettive sotto la spinta delle motivazioni interpersonali innate.
Questi contenuti e processi impliciti si rivelano in terapia attraverso modalità espressive non verbali, attivazioni emotive apparentemente improprie o sproporzionate, oppure tramite circolarità interpersonali disadattive che, di regola, coinvolgono anche il terapeuta. L’attenzione alla relazione terapeutica e alla sua modulazione divengono così veri e propri strumenti di cura. L’innesco del sistema di attaccamento nella relazione terapeutica, infatti, comporta inevitabilmente la riattivazione dei MOI dell’attaccamento, confermati e rafforzati nel corso dello sviluppo che ha seguito la prima infanzia. I MOI influenzano la percezione interpersonale e le vicissitudini dell’elaborazione dell’informazione emozionale, prima che queste divengano coscienti, rendendo difficile per il paziente l’esplorazione di significati alternativi, o la riflessione critica delle proprie aspettative, riattivando le stesse modalità di lettura del mondo apprese nell’infanzia attraverso la relazione con l’altro significativo.
Per certi aspetti, dunque, sono da ritenersi la controparte cognitivo-evoluzionista del concetto psicoanalitico di transfert, anche se tra i due vi sono differenze sostanziali (Liotti, 2001): ad esempio, nella prospettiva cognitivo-evoluzionista, alla base di quanto accade nel transfert, va riconosciuta in prima istanza l’attivazione del sistema motivazionale dell’attaccamento, e mai primariamente di quello sessuale o aggressivo. In particolare, l’esistenza di una pulsione primaria distruttiva è negata nella prospettiva cognitivo-evoluzionista.
La prospettiva cognitivo-evoluzionista rientra dunque tra quegli approcci psicoterapeutici di paradigma relazionale (molti di essi proprio di matrice psicoanalitica) che condividono la natura relazionale della mente e del suo sviluppo, la centralità delle dinamiche interpersonali di attaccamento per la comprensione della patologia e il ruolo sovraordinato della relazione terapeutica nel trattamento (Lingiardi et al. 2011; Bromberg, 2008; Liotti, 2011; Liotti e Farina, 2011). All’interno di questa concettualizzazione del funzionamento, quindi, anche l’inconscio,adeguatamente rivisto e depurato da alcuni concetti non sostenuti dalle evidenze sperimentali che nel corso dei decenni si sono imposte sul versante scientifico, è rientrato a far parte della pratica clinica, specie per quanto riguarda proprio la gestione e la modulazione di quei cicli interpersonali tra paziente e terapeuta che, se abilmente direzionati, possono divenire essi stessi potenti strumenti terapeutici.

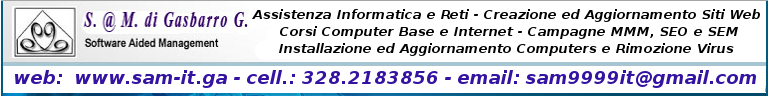


Lascia un commento