
Breve storia della verità assoluta
La filosofia è ricerca della verità, nel senso più generale possibile: verità sull’essere, sulla natura umana, sul dover essere (l’etica). La religione, almeno nell’accezione occidentale, si presenta come proposta di verità sui medesimi argomenti, di verità assoluta ed indubitabile. Può la filosofia raggiungere la verità assoluta? Può essere accettata la verità assoluta proposta da una religione?
La risposta alla prima domanda è no, la verità assoluta non è ottenibile tramite la ragione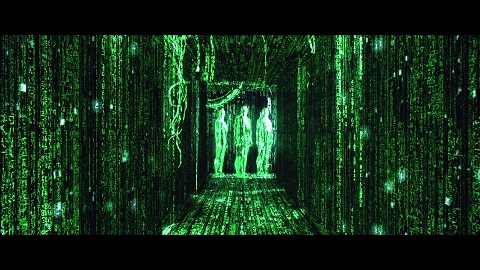 . Nei termini della filosofia occidentale tradizionale rimane insuperata la Critica della ragion pura di Kant, che libera il campo dalle “prove” dell’esistenza di Dio, ed enuncia assai bene il motivo per cui quelle che egli chiama idee della ragione sono destinate a rimanere prive di oggetto.
. Nei termini della filosofia occidentale tradizionale rimane insuperata la Critica della ragion pura di Kant, che libera il campo dalle “prove” dell’esistenza di Dio, ed enuncia assai bene il motivo per cui quelle che egli chiama idee della ragione sono destinate a rimanere prive di oggetto.
Anche accettando che non si possa dare contenuto alle idee della ragione, si potrebbe pensare che esista un altro modo di raggiungere la verità assoluta, attraverso la logica pura, che altro non è che il pensiero spinto all’estremo della formalizzazione. Kant riteneva che la verità matematica fosse assoluta in virtù delle forme trascendentali; i logicisti di fine Ottocento e primo Novecento speravano di arrivare al medesimo risultato attraverso un sistema logico formale. Ma il teorema di indecidibilità di Gödel ha definitivamente chiarito l’impossibilità di costruire il pensiero sulla sola forma della logica: nessun sistema di tal fatta potrà mai contenere tutta la verità, resteranno sempre verità indimostrabili formalmente. Quanto alle categorie kantiane, la fisica teorica le ha superate mostrando che è possibile costruire e verificare teorie scientifiche incompatibili con esse.
L’unica via d’uscita consiste nella chiara distinzione tra verità relativa e verità assoluta. Quest’ultima è irraggiungibile per l’essere umano; non sappiamo se vi siano altri esseri che l’hanno raggiunta o la possono raggiungere. La debolezza del pensiero umano fa sì che queste stesse argomentazioni ricadano comunque nella sfera del relativo.
I termini corretti della distinzione tra verità relativa e verità assoluta sono stati posti per la prima volta in modo esauriente dal filosofo indiano del II secolo Nâgârjuna. La corrente Mâdhyamaka del buddhismo Mahâyâna, da lui fondata, ha fornito le basi filosofiche del buddhismo tibetano, in particolar modo della scuola dGe-lugs-pa (pron. Ghelupa), e storicamente ha dato un contributo alla nascita della corrente cinese Chan ed infine allo Zen giapponese, ben presente ai nostri giorni anche se minoritario rispetto ad altre scuole buddhiste, e assai noto anche in occidente. Tali correnti hanno però abbandonato l’idea stessa di indagine sul piano del reagionamento, seguendo l’influenza del taoismo filosofico di Lao-zi e Zhuang-zi.
Un’analisi superficiale del Mâdhyamaka porta ad accostarlo alle correnti scettiche presenti sia in Oriente sia in Occidente: la sua dottrina sembra unicamente volta a distruggere le altre, senza proporre nulla di costruttivo. In questo modo si può arrivare allo scetticismo della Media Accademia o ai Cinici dell’antica Grecia, così come ai liberi pensatori del Settecento. In che cosa differiscono queste scuole, se tutte sostengono la fallacia di ogni forma di conoscenza?
Per chiarire questa differenza dobbiamo cominciare da una considerazione che potrà dispiacere a qualcuno, ma è indispensabile: chi sostiene la falsità di ogni teoria, deve però continuare a vivere, applicando ai fatti quatidiani della vita la ragione, la volontà, la sensibilità, l’intuizione, qualunque sia il concetto che egli ammette di avere al proposito. Ciò che rimane dipende in fin dei conti dalle basi culturali del filosofo più che da una costruzione deliberata del suo pensiero.
Il pensiero occidentale, però, è incardinato sulla ragione e sulla verità assoluta di tipo matematico (per i Greci geometrico): “Chi non conosce la geometria non entri” era scritto all’ingresso dell’Accademia. Questo deriva dal modo in cui la civiltà greca pose la matematica come modello ideale di conoscenza, avendola intesa per la prima volta come edificio logico piuttosto che come insieme di tecniche. La religione cristiana è un sincretismo di monoteismo semitico e filosofia ellenica, ed ha radicato ulteriormente il concetto che esistono verità assolute e ben definite: Dio è verità in primo luogo. “In principio era il logos” dice il Vangelo di Giovanni: Gesù Cristo si identifica con la parola/ragionamento di Dio. Attraverso il logos, Dio ha creato il mondo: le essenze vengono prima della creazione.
Ne risulta che il pensatore occidentale non trova altre possibilità, oltre alla ragione ed alla fede. Ma lo scetticismo le travolge entrambe, perché la religione occidentale è intrisa di ragione. Il cristianesimo storico, infatti, è identificato da un insieme di dogmi, che sono asserzioni dotate di significato soltanto se il linguaggio e la logica sono dati. L’esistenza di Dio e dell’anima sono intese come verità assolute, ma se il concetto stesso di Dio, il concetto di anima, il concetto di esistenza non si possono fondare in qualche modo sul linguaggio e sulla ragione, allora i dogmi diventano formule vuote. In principio era il logos – che in greco significa insieme parola/pensiero/ragione.
Il pensiero orientale non ha introdotto questa premessa. Ad esempio, la parola dei Veda è prima suono, poi significato, secondo la mimâmsâ (una delle sei scuole tradizionali vediche, o darsana), ed è assoluta in quanto suono, non in quanto significato. In principio era il sabda – il suono / la sillaba cosmica Om.
Il buddhismo, abbandonando la rivelazione vedica, abbandonò anche quei concetti metafisici, pur presenti nel pensiero delle scuole vediche, che risultano più familiari all’occidentale: il Dio personale, l’esistenza stessa dell’anima. Le divinità passano in secondo piano rispetto ai buddha e ai bodhisattva, i quali sono esseri che hanno raggiunto l’illuminazione attraverso una catena di esistenze. Le varie scuole differiscono tra loro su singoli punti metafisici, ma il concetto fondamentale dell’impermanenza e del vuoto come fondamenti del mondo dell’apparenza sono comuni a tutti. Per chiarezza di chi non conosce il pensiero buddhista, ricordo che l’individuo e l’anima non sono considerati reali, e la catena delle esistenze è da intendersi come processo che continua e non come persistenza di un essere: si può paragonare alla fiamma di una candela, o ad un fiume che scorre. La reincarnazione è come l’atto di accendere una candela con un’altra che sta per spegnersi: la fiamma non è più la stessa, anche se in qualche modo è la continuazione della precedente.
Il passo ulteriore compiuto da Nâgârjuna consiste nel negare, sul piano dell’assoluto, la stessa dottrina buddhista. Questa, nelle sue diverse versioni, rimane valida sul piano della verità relativa, come mezzo pratico per raggiungere l’illuminazione. Si tratta di uno sviluppo del tutto naturale, se si considera che il Buddha storico, come ci è riportato dai testi più antichi del Canone pâli, esplicitamente affermava di voler insegnare un metodo e non una metafisica.
Il Chan e quindi lo Zen hanno portato all’estremo questo atteggiamento, abolendo qualsiasi insegnamento dottrinale. L’illuminazione viene cercata unicamente per mezzo della meditazione. Ma i metodi Chan/Zen sono adatti soltanto a persone già munite di qualità intellettuali particolari (senza intendere con questo il grado di istruzione, che può essere irrilevante), capaci di saltare direttamente al di là della fase razionalistica.
La quotidianità della vita, da cui siamo partiti, viene esaltata da queste scuole al punto di diventare l’oggetto centrale della meditazione: la tathata, che si è provato a tradurre con “quiddità”, l’evento in sé che precede ogni elaborazione. Secondo la scuola dell’illuminazione improvvisa, il più insignificante dei fatti quotidiani può suscitare l’illuminazione di una persona.
Altre scuole, come la già citata dGe-lugs-pa, che si ispira appunto al Mâdhyamaka di Nâgârjuna, danno invece grande importanza alla logica come strumento per l’insegnamento ed il consolidamento della dottrina.
Da un punto di vista occidentale, si tratta di una contraddizione: si usa un mezzo del quale si afferma fin adll’inizio l’inadeguatezza. Ma le dottrine orientali si presentano come vie, non come sistemi. Sono procedimenti, metodi, non strutture organizzate staticamente. La ragione non consente da sola di percorrere tutto il cammino, ma è usata per percorrerne un certo tratto; anzi in questa fase è considerata indispensabile, dal Mâdhyamaka. Altre scuole ne fanno a meno, perché si rivolgono a persone diverse: nessuna via è adatta a tutti.
Ciò che è comune sostanzialmente a tutto il pensiero orientale è il riconoscimento che la conoscenza più alta è di tipo non verbale, non discorsivo: “il discorso supremo è senza parole” (Zhuang-zi). In Oriente si accetta che si possa (secondo alcuni si debba) partire dal ragionamento per arrivare alla sapienza (prajña) che è al di là di esso; non esiste il concetto di fede. La prajña non è fede, è conoscenza diretta dell’assoluto ottenuta attraverso un metodo, una via; non è traducibile in articoli formalizzati, non è compatibile con un “credo” come quello cristiano di Nicea, perché la prajña non è esprimibile a parole e qualunque formula verbale vale soltanto come mezzo, come appoggio, per indirizzarsi alla sapienza, ma è intrinsecamente incapace di esprimere la verità assoluta.
Per gli occidentali, invece, la fede è certezza assoluta della formula: se dico “Credo in Dio padre … creatore del cielo e della terra” vuol dire che pongo quest’affermazione in modo assoluto al di là di ogni dubbio e di ogni discussione. Intendo quindi veramente che è indiscutibile che ci sia un Dio che ha creato il mondo. Si tratta in realtà di una sintesi di filosofia occidentale e religiosità semitica: la parola è assoluta per il suo significato, come una dimostrazione geometrica è assoluta per la sua struttura logica, ma si prende come punto di partenza il testo sacro o il dogma. La cultura occidentale è permeata da questo concetto, tanto che gli stessi scienziati, anche quando sono in urto con l’autorità religiosa, mantengono questo atteggiamento: Galileo diceva che Dio si esprime in linguaggio matematico. Con somma ironia, coloro che si appellano ai libri sacri contro la scienza assumono il medesimo atteggiamento, perché prendono tali libri alla lettera, come se fossero testi scientifici. Il “credo” è quindi trattato come gli assiomi di Euclide: verità autoevidente per il suo contenuto, da cui derivare ogni ragionamento.
Siamo quindi giunti al punto cruciale: la fede monoteistica occidentale non è affatto svincolata dal logos, anzi se ne serve in modo assoluto, costruendo un “sistema euclideo” basato sugli articoli di fede. Lungi dall’essere alternativa alla ragione scientifica, essa se ne allontana soltanto perché pone delle premesse inviolabili basate sui testi sacri, anziché sulla pura ragione o sull’evidenza fisica. Pertanto la sua pretesa di proporre una verità assoluta è soggetta alle stesse argomentazioni che portano al fallimento il tentativo analogo fatto dalla filosofia: nel momento in cui la religione si pone come forma di conoscenza logica e formalizzata, si sottopone al medesimo tipo di attacco argomentativo a cui la conoscenza filosofica soccombe.
Questa pretesa di verità formale, per essere corretti, non era propria del monoteismo più antico, l’ebraico. L’atteggiamento ebraico non è quello di cercare la letteralità del significato, ma il potere della parola: non logos (parola/ragionamento logico) ma davar (parola/azione). Gli Ebrei non hanno dogmi, hanno la Torah. Anche fra loro ci sono quelli che la usano in senso dogmatico di tipo logico, ma in fondo essi tradiscono la propria cultura riassorbendo atteggiamenti più ellenici, cristiani o mussulmani che ebraici. Non procedo oltre nell’approfondimento della religiosità ebraica, che meriterebbe altro spazio, per tornare alla questione della verità assoluta. Mi limito a dire che a mio parere, spogliandola degli aspetti dogmatici, che di per sé non sono ebraici, essa può trasformarsi in una via verso la verità, attraverso la quale si potrebbe ricostruire anche il cristianesimo.
Riassumendo quanto si è detto finora, si può affermare che il pensiero occidentale crea una struttura di tipo logico-discorsivo sopra alcune premesse di tipo fideistico (nel campo della religione) o di “evidenza empirica” (nel campo della scienza). Il pensiero orientale invece parte da una visione tradizionale del mondo per analizzarla e poi smantellarla con il ragionamento, per procedere successivamente (o parallelamente) all’abbandono del metodo logico-discorsivo in favore del metodo meditativo-intuitivo.
Il pensiero occidentale, dunque, è pervenuto ad un punto critico. La logica matematica ha dimostrato la propria stessa insufficienza, col teorema di Gödel: non è possibile fondare la logica e la matematica soltanto su loro stesse. La scienza fisica, intanto, si è totalmente svincolata dalle normali categorie del pensiero umano, prima con la relatività e poi con la meccanica quantistica. Tempo, spazio, sostanzialità della materia sono diventati qualcos’altro di indefinibile in termini del linguaggio comune. La fisica offre oggi un metodo estremamente preciso ed efficace per descrivere i fenomeni, ma è intraducibile nel linguaggio quotidiano. Si possono criticare taluni aspetti formali del famoso libro di Fritjof Capra “Il Tao della fisica”, ma è vero che la fisica quantistica è più compatibile con Buddha e Lao-zi che con Aristotele e Kant.
Ora possiamo spiegarcene il motivo: la scienza opera per alcuni aspetti come il pensiero orientale, non come il pensiero ellenico! I grandi scienziati del passato, a partire da Galileo, erano troppo intrisi di pensiero occidentale per rendersene conto.
I fondatori della scienza moderna, infatti, credevano di operare come Euclide: scoprire gli assiomi, ricavabili dalla natura ma assoluti e definitivi una volta scoperti, e derivare col ragionamento tutto il resto. La verifica empirica avrebbe dovuto semplicemente confermare o refutare la validità degli assiomi. Ma qui sta il punto: non è mai possibile verificare gli assiomi in modo assoluto. Il metodo galileiano è sempre stato giusto, ma Galileo stesso credeva che le sue scoperte, una volta confermate dall’esperienza, fossero definitive. La fisica della fine dell’Ottocento e del primo Novecento mise in crisi questa concezione del sapere scientifico: Einstein, ad esempio, dimostrò che le scoperte di Galileo e Newton non erano definitive neppure nel campo apparentemente più solido, la dinamica del punto materiale. Non che fossero sbagliate, la fisica classica era semplicemente un’approssimazione valida in un certo ambito di condizioni.
Si è quindi reso evidente che il metodo scientifico è per l’appunto un metodo, una via. Un metodo straordinariamente efficace per descrivere certi ambiti di fenomeni. Alla sua base, il concetto più importante: nessuna scoperta è mai definitiva, nessuna formulazione è valida in modo universale. E’ possibile procedere verso una conoscenza sempre migliore dei fenomeni, ma non si può mai avere la conoscenza assoluta.
La meccanica quantistica ha mostrato come una teoria scientifica può descrivere con grande precisione i fenomeni rimanendo intraducibile nel linguaggio ordinario; meglio, la sua traduzione contiene contraddizioni non eliminabili. Se non ci si preoccupa di questo e si guarda il risultato, va tutto perfettamente. Ma questo è un atteggiamento orientale: non esiste una verità assoluta descrivibile a parole, esistono però metodi validi per raggiungere la conoscenza. Non c’è da meravigliarsi, quindi, che la scienza contemporanea si adatti ad una visione buddista o taoista del mondo fenomenico: buddisti e taoisti da sempre negano qualsiasi dogma, qualsiasi essenza, qualsiasi discorso definitivo sul mondo.
Il mondo orientale non ha saputo sviluppare la scienza, perché non ha attraversato una fase in cui si sviluppasse la fiducia nella matematica come metodo. Viceversa, l’Occidente si è ritrovato privo di una disciplina spirituale capace di progredire con le sue capacità scientifiche, perché ha sviluppato una religiosità dogmatica, per la quale la matematica è intesa come modello anziché come metodo.
Oggi l’Occidente ha raggiunto una certa consapevolezza di aver perduto la verità assoluta. La maggioranza degli occidentali cerca di ritrovarla nella fedeltà alla religione tradizionale. Le scuole di pensiero non religiose sono in disarmo; per ultimo è caduto il marxismo. Ma non ha via d’uscita, perché le scuole di pensiero occidentali sono permeate di dogmatismo. Del pensiero orientale si colgono gli aspetti superficiali, magici, ciarlataneschi, mentre le grandi tradizioni spirituali sono ignote ai più.
Ciò che di meglio ha creato l’Occidente è la scienza, che per definizione non cerca la verità assoluta ma la miglior spiegazione disponibile. Ciò che di meglio ha creato l’Oriente è l’indagine sulla natura umana nella sua componente spirituale, indagine rivolta a trovare il metodo per liberare l’uomo dalle angustie della sua condizione.
Dobbiamo quindi ricostruire una visione del mondo che tenga conto di entrambe le tradizioni dell’umanità. Ciò che hanno in comune le parti migliori di entrambe è il porsi come metodi e non come punti di arrivo preordinati. Non è sincretismo, significa accogliere il punto di vista secondo il quale per ogni cosa ci sono metodi, tecniche, vie, nessuna delle quali valida in assoluto, tutte utili nei rispettivi ambiti. La verità assoluta è irraggiungibile, se non attraverso un cammino spirituale individuale. Sta a ciascuno di noi trovare la propria via, conservando il rispetto per le altre.
Alberto Cavallo, 14 agosto 2000
La Grande Via è priva di porta
ma esistono migliaia di sentieri.
Una volta che se ne penetri la barriera
s’incede, da soli, nell’universo. [Dal Wu-men kuan]
L’inattingibilità della verità assoluta
La definizione della verità sembra uno dei problemi filosofici più difficili. Si può addirittura pensare che, se si riuscisse a definire la verità, allora la si conoscerebbe completamente! Cerchiamo dunque di non smarrirci, procedendo in modo sistematico: molti problemi filosofici sono resi difficili a causa della mancanza di sistematicità, come ci hanno insegnato i logici moderni.
Adottiamo dunque la classica definizione della verità come corrispondenza tra linguaggio e fatti: diciamo che una proposizione è vera se essa esprime (è in corrispondenza con) un fatto vero. Questa è sostanzialmente la definizione di Aristotele, da cui Alfred Tarski ha sviluppato la versione della logica matematica. Ora non stiamo seguendo un procedimento logico in senso stretto, per cui la definizione va bene così.
Come tutte le definizioni, la nostra ha spostato il problema alla definizione dei termini che introduce: “linguaggio” e “fatto”. Il linguaggio a cui ci riferiamo dovrebbe essere il linguaggio umano in senso lato, intendendo con questo l’insieme di tutti i linguaggi naturali e artificiali dell’uomo. Perché dovremmo adottare una definizione così estesa? per il fatto che vogliamo parlare di verità assoluta: qualunque restrizione renderebbe la definizione inadeguata.
Per quanto riguarda i “fatti”, la definizione dev’essere di nuovo la più generale possibile. Un fatto sarà dunque tutto ciò che rientra nella sfera dell’esperienza, della ragione, dell’intuizione, della trascendenza, ivi compresi gli enti più elevati e generali (il mondo, Dio, il brahman ecc.).
E’ dunque possibile che una proposizione del linguaggio umano sia corrispondente in modo assoluto con un fatto assoluto? Il fatto stesso che si tratti del linguaggio “umano” fa sì che una corrispondenza incondizionata, assoluta con un fatto incondizionato, assoluto sia impossibile, dato che l’uomo, e quindi il suo linguaggio, per sua natura è limitato. Nessuna proposizione del linguaggio umano può esprimere l’assoluto. Il linguaggio umano, indissolubilmente legato con la ragione umana, a sua volta legata alla natura umana in generale, introduce di per sé una limitazione in ciò che può esprimere.
In base alla definizione che abbiamo dato, la verità assoluta, quindi, non è esprimibile.
Si può a questo punto obiettare che la definizione che abbiamo scelto era ancora troppo restrittiva, nonostante gli sforzi fatti per renderla la più generale possibile.
Possiamo togliere la restrizione relativa alla sfera del linguaggio: accettiamo anche linguaggi non umani. Ma per definizione, un linguaggio realmente non umano ci è inaccessibile. Un linguaggio non umano a noi accessibile sarebbe riducibile al linguaggio umano, per cui non eliminerebbe la restrizione. Saremmo infatti in grado di individuare regole di traduzione nel nostro linguaggio, o almeno nei concetti che sono alla base del linguaggio. Ma alla base del linguaggio è la capacità di distinzione e concettualizzazione dell’intelletto umano, che per sua natura non è assoluta, per il fatto stesso di introdurre distinzioni sulla base delle facoltà di un essere limitato.
Dal nostro punto di vista, una verità riferita ad un linguaggio non umano è inaccessibile sul piano dei concetti, quindi a tutti gli effetti per noi non esiste.
Si può allora pensare di togliere completamente di mezzo il linguaggio. A questo punto, però, l’argomentazione filosofica, che per sua natura fa ricorso al linguaggio, si ferma. La verità assoluta si dovrà perseguire attraverso la sapienza spirituale (prajña), da raggiungersi con mezzi non linguistici e quindi non propri dell’intelletto, bensì di qualche altra facoltà spirituale.
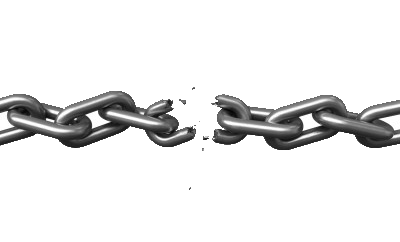 “La Via suprema non ha nome; il discorso supremo non ha parole.” [Zhuang-zi, cap. II].
“La Via suprema non ha nome; il discorso supremo non ha parole.” [Zhuang-zi, cap. II].
L’inesistenza inerente: le essenze non esistono
Che cosa vuol dire, realmente, “X esiste”? Noi crediamo nell’esistenza di moltissime cose, in tutte le sfere che la nostra tradizione culturale riconosce. Quando diciamo che qualcosa esiste, intendiamo di solito che vi è oggettivamente un’entità perfettamente definita, indipendente da noi, che costituisce il supporto delle nostre percezioni o dei nostri concetti. Si tratta della sostanza aristotelica, composta di materia e forma. Siamo infatti tutti in qualche modo aristotelici, nella vita di tutti i giorni. Ma analizziamo alcune entità significative, per cercarne l’essenza o la sostanza.
L’esistenza degli oggetti materiali macroscopici è stata analizzata magistralmente nel classico testo buddhista intitolato Milindapañha, in cui il monaco buddhista Nâgâsena dimostra al re greco Milinda (Menandro) che il suo carro non esiste. Considerando una per una le parti del carro, si vede che nessuna di esse è il carro; peraltro si dice che c’è il carro quando queste parti, perfettamente distinte, sono viste come un insieme. Separando le parti che costituiscono il carro, il carro svanisce, “carro” si rivela essere il nome convenzionale di un insieme di pezzi. Proviamo per di più a pensare a quello che accade smontando due carri, mescolandone le parti e rimontandoli a caso, realizzando due nuovi carri con le parti mescolate dei due originari. Che fine fa l’identità dei carri originari?
Non si sfugge quindi all’inesistenza del singolo oggetto materiale. Come i filosofi occidentali (Locke, Hume, Kant) hanno riconosciuto per altra via, la sostanza è una categoria dell’intelletto. I singoli oggetti non hanno essenza propria.
Ma gli universali? E’ sufficiente leggere il codice della strada, tanto per restare nell’argomento dei carri e dei mezzi di trasporto dotati di ruote, per vederli svanire. Che cos’è un’automobile? in che cosa differisce da un motociclo o da un autocarro? Le definizioni di questi oggetti si rivelano, ad un’attenta analisi, del tutto arbitrarie: è previsto, ad esempio, un veicolo chiamato quadriciclo, esiste l’autoveicolo, mentre l’automobile non esiste. Confrontando le definizioni del codice stradale italiano con quelle comunemente adottate nel linguaggio di tutti i giorni, ci si rende conto che la classificazione dei veicoli può essere fatta nei modi più svariati. Il senso comune finisce per adottare definizioni che risultino comode per l’uso quotidiano, senza troppe sottigliezze.
La forma aristotelica, quindi, ha un’esistenza propria? Senz’altro no. La forma di un oggetto esiste solo in relazione con qualcuno o qualcosa che percepisce e classifica quell’oggetto. L’esperto di razze canine vede in quell’animale che sta passando un “dobermann” piuttosto che un “boxer” o un “terrier”. L’inesperto vede un “cane” e basta. Nessuno dei due ha torto, anche se si potrebbe obiettare che uno dei due ne sa di più, e la sua classificazione è più raffinata. Quest’osservazione ci fa capire che solo nell’ambito di una cultura si configura la verità, che rimane pur sempre relativa. Ciascun oggetto è “veramente” ciò che gli esperti di quel tipo di oggetto ne dicono. Soltanto l’intera popolazione che rientra in un ambito dato può, attraverso l’unione delle sue conoscenze, definire tutti gli oggetti con cui è in contatto. Ma questo significa che culture diverse avranno visioni diverse. I cinesi (esperti) vedono nel cielo stellato costellazioni del tutto diverse da quelle che vedono gli occidentali (esperti).
La fisica moderna ha distrutto la sostanza in modo ancor più profondo. Le entità materiali si possono interpretare come particelle o come onde. Le due interpretazioni sono incompatibili, ma valgono contemporaneamente. Il paradosso si risolve perfettamente nella formulazione matematica della meccanica quantistica, ma non è traducibile nelle categorie ordinarie del pensiero umano (sottolineo che questi sono concetti comunemente accettati dai fisici).
Ma noi stessi siamo fatti di particelle – che non sono realmente particelle! Tutto il mondo fenomenico, secondo la fisica del XX secolo, si fonda su entità a cui non si può applicare la tradizionale categoria di sostanza. Infatti tale categoria è applicabile alle particelle, non alle onde, ma la fisica ci dice che le particelle sono anche onde.
Le particelle, allora, esistono o no? E noi stessi?
Innanzitutto, occorre accettare che l’oggetto non esiste senza un soggetto, ovvero che qualcosa esiste o non esiste soltanto in rapporto ad un osservatore. Si tratta di una conclusione idealistica? Qual è la condizione delle montagne della faccia nascosta della Luna? E delle montagne dell’Archeozoico?
L’esistenza nell’apparente assenza di chi la può verificare si può risolvere così: una montagna dell’Archeozoico non aveva nessuno che la vedesse e quindi la classificasse e le desse un nome, pur notando che c’è molta arbitrarietà nel definire una montagna; la sua esistenza in qualche modo fa parte di una catena di fenomeni che giungono fino a noi, per cui può essere dedotta. L’esistenza di cose assolutamente non riconducibili a noi ricade nella sfera dell’arbitrario, del mito. Dire “c’è o c’è stato un universo privo di osservatori” può avere senso sulla base di una teoria dell’origine degli universi, ma proprio in quanto tale teoria stabilisce un legame, e noi diventiamo osservatori indiretti di tale universo. Indagando su di esso produciamo eventi che ci portano a fare deduzioni ed a costruirci un concetto di tale universo.
Ma l’universo non è prodotto dal soggetto: la risposta del dottor Johnson a Berkeley che sosteneva l’inesistenza della materia fu un calcio ad un sasso. La risposta, nella sua non verbalità, era perfetta: il punto di partenza è quello che nella filosofia buddhista si chiama tathata, che potremmo chiamare “esperienza elementare non elaborata dall’intelletto”. Essa è alla base delle cose, è la cosa in sé di Kant. Ciascuno di noi soggettivamente la sperimenta, non la produce; essa è anteriore al soggetto ed all’oggetto, sottraendosi quindi all’oggettività cercata dalla scienza come anche alla soggettività di stampo idealistico. L’elaborazione compiuta dall’intelletto, poi, crea la realtà oggettiva, che va intesa in generale come costruzione intellettuale, come discorso/razionalizzazione (logos).
Attraverso il metodo scientifico, che si basa sull’elaborazione di teorie basate sul linguaggio matematico e sulla sperimentazione galileiana, si raggiunge un tipo di conoscenza oggettiva, come tale condivisibile da tutti coloro che comprendono il metodo. Gli aspetti legati al soggetto sono eliminati. Questo costituisce un limite del metodo scientifico, tant’è vero che che la sua applicazione allo studio della mente umana si sta scontrando con l’impossibilità di descriverne gli aspetti soggettivi.
Le esperienze meditative dei mistici orientali sono anch’esse il frutto di procedure riproducibili, quindi costituiscono un metodo alternativo di conoscenza, riferito alla sfera non discorsiva. La condivisione avviene attraverso la ripetizione di un’esperienza irriducibilmente soggettiva.
Non si tratta di due alternative fra le quali si deve scegliere: sono invece metodi di accesso a sfere diverse, entrambe però presenti nella natura umana, che è simultaneamente razionale ed irrazionale.
Soltanto la piena consapevolezza dell’inaccessibilità della verità assoluta discorsiva ci consente di affrontare l’esistenza in modo totalmente libero da pregiudizi, riportando ogni questione nella sua propria sfera. Le contrapposizioni culturali non scompaiono, ma acquistano una funzione costruttiva. Spazzato il campo dalle essenze, possiamo vedere ogni cosa in una luce nuova; soprattutto, possiamo riconoscere che esistono diverse vie verso la conoscenza, senza per questo cadere nel relativismo culturale.
Alberto Cavallo, 29 dicembre 1997
Nota filologica
Questa pagina contiene una parte introduttiva generale, completamente riscritta sulla base di un testo precedente, e due brevi articoli da me scritti alcuni anni fa e rimasti sostanzialmente inalterati.
Il testo contiene parole tratte da linguaggi che non si scrivono con l’alfabeto latino. Le limitazioni di HTML e la necessità di evitare problemi in base ai settaggi dei browser e dei sistemi operativi mi hanno indotto a scegliere metodi di trascrizione o traslitterazione che richiedono qualche chiarimento.
Per il sanscrito ho incontrato le difficoltà maggiori, dato che sarebbero necessari segni diacritici non disponibili nei normali set di caratteri. Ho usato l’accento circonflesso per indicare le vocali lunghe ed ho semplicemente omesso i segni diacritici non disponibili, piuttosto che inserire ad esempio delle h supplementari, all’inglese, che finiscono di confondersi con quelle richieste dalla trascrizione rigorosa.
Per il tibetano ho usato la traslitterazione più rigorosa, indicando la pronuncia ove necessario, dato che questa lingua è afflitta dal medesimo problema dell’inglese: una distanza tremenda tra grafia e pronuncia.
Per il cinese ho usato il pinyin, che ormai è la trascrizione latina più comune, salvo che per la parola tao, che si dovrebbe scrivere dao. Mi sembrava buffo scrivere dao e parlare di taoismo(daoismo?).
Per il greco il testo non contiene parole con traslitterazione ambigua.
Per il giapponese ho adottato la trascrizione più comune, senza segni di quantità sulle vocali.
Per l’ebraico la trascrizione è puramente fonetica (rende la pronuncia).
Fonti delle citazioni
1. Leonardo Arena, Antologia del buddhismo Ch’an, Oscar Mondadori 1994;
2. Zhuang-zi (a cura di Liou Kia-hway), Adelphi 19932
Domanda: “Cosa è giusto? E cosa no? Come fai a sapere qual è la verità?”
Risposta: “Semplice, la verità è quella in cui tu sei d’accordo mentre l’ascolti!”
(Paxton Robey)

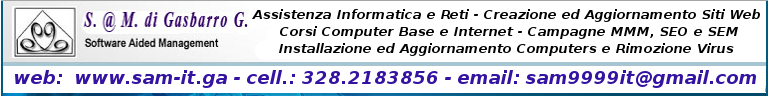


Lascia un commento