
A cosa servono i rituali. Diverse ricerche recenti hanno misurato e descritto gli effetti psicologici e fisiologici di gesti apparentemente privi di senso ma legati a bisogni umani fondamentali. I rituali scaramantici sono una pratica molto diffusa in diversi ambiti tra cui, notoriamente, nello sport. Nei primi anni della sua carriera, prima di ogni partita, il giocatore di basket americano LeBron James era solito cospargersi le mani di gesso e poi lanciarlo in aria.
Prima di ogni partita, l’ex calciatore e capitano della nazionale francese Laurent Blanc dava un bacio in testa al suo compagno di squadra Fabien Barthez. E il tennista spagnolo Rafael Nadal è molto noto, tra le altre cose, per una serie di articolati rituali svolti prima, durante e dopo ogni match: dal posizionare le bottigliette d’acqua in un certo modo al non calpestare le linee del campo quando il gioco è fermo.

Benché siano spesso associati ad azioni superstiziose e irrazionali di singoli individui, i rituali sono anche una parte fondamentale di molte pratiche collettive, cerimoniali e istituzionali: dal sollevare un bicchiere per fare un brindisi al passare una campanella al nuovo presidente del Consiglio da parte del suo predecessore per sancire, in Italia, l’insediamento di un nuovo governo.
La ricerca antropologica ed etnografica ha esplorato per oltre un secolo le funzioni dei rituali, mostrando quanto siano fondamentali in tutte le civiltà umane per il mantenimento dell’ordine sociale. Ma in tempi più recenti l’utilizzo più esteso e sistematico di discipline come la psicologia e di strumenti non disponibili in passato hanno permesso di misurare dal vivo e non in laboratorio gli effetti fisiologici dei rituali sulle persone. E questo ha permesso di testare empiricamente molte ipotesi note sui rituali e scoprire quanto siano influenti per la gestione dell’ansia e la variabilità della frequenza cardiaca, per esempio, estendendo la nostra comprensione di fenomeni che sono legati a necessità primordiali degli esseri umani.
In tutte le società umane conosciute sono attestate tradizioni che includono comportamenti formalizzati e stereotipati, eseguiti in momenti particolari della vita delle persone: in genere momenti che associamo al concetto di «soglia», di passaggio da una fase a un’altra. Molti studi di antropologia ed etnografia hanno descritto quei momenti come quelli in cui è percepito da parte dell’individuo all’interno della comunità un rischio più alto che qualcosa possa andare storto.
Come osservò l’etnologo, antropologo e filosofo italiano Ernesto De Martino, uno dei più influenti studiosi del Novecento nella ricerca sulla ritualità e sulla religiosità popolare, l’incertezza e l’imprevedibilità insite in quelle particolari situazioni pongono di fatto il rischio di una «crisi», di un fallimento potenzialmente irreversibile per l’individuo. E il rituale sarebbe il modo con cui, cercando di rendere familiare un evento rischioso e dall’esito non del tutto prevedibile, le culture tradizionali riducono il rischio di una crisi e proteggono i propri membri.
Eppure molti dei comportamenti che definiamo rituali non hanno uno scopo esplicito. E in generale, anche laddove sia chiaro l’obiettivo del rituale, non esiste un nesso causale evidente tra quello scopo e l’azione intrapresa per raggiungerlo. Non esiste un nesso causale tra la pioggia e la danza eseguita per invocarla, per esempio. E neppure tra uno specifico lamento funebre e il superamento del lutto.
L’assenza di una funzione che sia immediatamente chiara è peraltro una delle caratteristiche che distinguono il rituale dalle abitudini. Lavare i denti prima di andare a dormire, per esempio, fa parte di una routine eseguita senza riflettere e secondo un modello ripetitivo, come i rituali. Ma rimane ciononostante un’attività con una funzione immediata e un effetto diretto e non simbolico sul mondo, certamente diverso da quello che attribuiremmo all’uso di uno spazzolino da denti per fare un segno della croce.

Come affermato negli anni Quaranta dal sociologo statunitense George Homans, una delle ragioni per cui definiamo rituali certe azioni è proprio che «non producono un risultato pratico sul mondo esterno». E in passato, quando i rituali erano invece praticati avendo un obiettivo esplicito in mente, in molte comunità religiose erano spesso considerati stregoneria. Che non significa che i rituali non abbiano alcuna funzione, scriveva Homans, segnalando quanto siano efficaci nel «dare fiducia ai membri della società, dissipare le loro ansie, disciplinare le loro organizzazioni sociali».
È probabilmente questa la ragione per cui, nonostante la conclamata incommensurabilità tra azioni intraprese e obiettivi perseguiti, i rituali sono ancora oggi un fatto comune quanto lo erano in epoche remote: a prescindere da quanto siano poi praticati individualmente e collettivamente, in contesti religiosi o secolari, nelle società più laiche e in quelle meno laiche.
Nel suo recente libro How Seemingly Senseless Acts Make Life Worth Living, l’antropologo e scienziato cognitivo greco Dimitris Xygalatas, docente di antropologia e scienze psicologiche alla University of Connecticut, ha riportato i risultati di una serie di studi – suoi e di altri ricercatori e ricercatrici – sugli effetti dei rituali sulle persone. E ha spiegato che le difficoltà delle scienze sperimentali applicate all’ambito di studi dell’antropologia sono state per lungo tempo legate all’impossibilità di effettuare misurazioni affidabili in contesti reali e non in laboratorio.
Negli ultimi decenni, lo sviluppo di nuovi strumenti e tecnologie – dai sensori biometrici indossabili alle risonanze magnetiche funzionali (fMRI) – ha permesso a scienziati sociali di varie discipline di studiare in modo più approfondito e dettagliato il valore di molte pratiche rituali all’interno delle società. E le loro scoperte hanno in molti casi prodotto dati a sostegno dell’ipotesi, in precedenza formulata dagli antropologi, che il rituale sia un tratto profondamente radicato nella storia evolutiva della specie umana.

In uno studio del 2011, condotto su gruppi di donne israeliane durante la guerra del Libano nel 2006, i ricercatori scoprirono che recitare i salmi era associato a livelli più bassi di stress e di ansia riferiti dalle persone in zone di guerra, rispetto a quelle del gruppo che si era trasferito in parti del paese più sicure. L’ipotesi dei ricercatori fu che la recitazione dei salmi riducesse l’ansia causata dalle condizioni incontrollabili della guerra ma che non fosse ugualmente efficace nel contrastare fattori di stress più banali e controllabili.
Effetti simili a quelli riportati nello studio del 2011 e in altri sono stati riscontrati non soltanto sul piano soggettivo, cioè attraverso le impressioni degli individui intervistati, ma anche a livello fisiologico. Per uno studio pubblicato nel 2020 insieme a due ricercatori dell’Università Masaryk a Brno, Xygalatas condusse un esperimento nella città di La Gaulette nell’isola di Mauritius, nell’oceano Indiano, per misurare gli effetti di alcuni rituali tradizionali sugli abitanti.
Xygalatas e i colleghi si concentrarono sulla variabilità della frequenza cardiaca, cioè la misura di quanto varia – durante un certo periodo di tempo, più o meno lungo – il tempo che intercorre tra un battito e un altro. Dal momento che un cuore sano non batte come un metronomo, avere una frequenza cardiaca di 60 battiti al minuto non significa che il cuore batta esattamente una volta al secondo: significa che, in un minuto, tutti i periodi leggermente diversi tra due battiti durano in media un secondo.
Di solito, un’alta variabilità della frequenza cardiaca indica una normale condizione del sistema nervoso autonomo (quello che controlla le funzioni degli organi interni come cuore, stomaco e intestino) e una maggiore capacità di adattamento a circostanze mutevoli. Al contrario, una bassa variabilità indica maggiori livelli di ansia e di stress, conseguenza di un continuo e rigido stato di allerta.
All’esperimento parteciparono 75 donne di La Gaulette di fede induista, tra le molte che ogni mattina si recavano in un piccolo tempio della città per le preghiere ordinarie. Quelle preghiere prevedevano, tra le altre cose, una serie di azioni ripetitive e movimenti rituali con bastoncini di incenso. Tutte le donne indossarono un sensore per registrare il battito cardiaco, ma a un gruppo fu chiesto di sottoporsi all’esperimento nel tempio, e a un altro gruppo di farlo in un laboratorio provvisorio ricavato in un edificio simile al tempio per dimensioni e per disposizioni dei mobili.

Prima di tutto, Xygalatas e gli altri ricercatori chiesero alle donne di descrivere dettagliatamente quali precauzioni avrebbero preso in caso di inondazioni o cicloni: il genere di disastri naturali che generano maggiore ansia alla gente dell’isola. E per incrementare il livello di stress, dissero loro che quel rapporto sarebbe stato valutato da esperti di sicurezza pubblica. Dopodiché, alle donne del gruppo nel tempio fu chiesto di andare nella sala delle preghiere e svolgere i rituali di sempre; a quelle dell’altro gruppo, in laboratorio, fu chiesto di andare in un’altra sala per sedersi e rilassarsi.
Lo studio mostrò gli effetti benefici del rituale, dopo che i sensori avevano registrato un aumento dell’ansia in entrambi i gruppi. Il gruppo nel tempio si riprese più velocemente rispetto a quello in laboratorio, incrementando la variabilità della frequenza cardiaca del 30 per cento rispetto all’altro gruppo (valori più alti, come detto, sono associati a minori livelli di stress), e in modo coerente rispetto anche alle valutazioni soggettive.
Riprendendo un argomento noto nella letteratura scientifica come «modello di controllo compensatorio», Xygalatas sostiene che le proprietà che rendono prevedibili i rituali – la rigidità, la ripetizione e la ridondanza delle formule – sono ciò che permette alle persone di ricavare la percezione di avere un controllo su situazioni che sono incontrollabili. Non è casuale quindi che il ricorso al rituale, come nel caso del rischio di crisi teorizzato da De Martino, sia più probabile quando le persone sperimentano incertezza e mancanza di controllo.
Ed è per questo che le pratiche rituali tendono a emergere in molti contesti della vita che implicano una posta in gioco più o meno alta e vari gradi di incertezza dei risultati: dall’esito di una partita di tennis all’insediamento di un nuovo governo. Secondo uno studio di psicologia del 2010 sulle relazioni tra la superstizione e la fiducia nel padroneggiare certe situazioni, le persone che utilizzano portafortuna e svolgono rituali come tenere le dita incrociate, se viene vietato loro di farlo, tendono a cavarsela peggio in vari giochi di abilità.
Altri studi hanno mostrato che nel basket e nel golf le routine personali seguite da ciascun atleta prima di un tiro possono migliorare le prestazioni, e che vietare di seguire quelle routine può invece peggiorare le prestazioni. E la ragione di questi effetti risiede generalmente nella capacità di quei rituali di ridurre l’ansia e dare agli atleti un’impressione di controllo della situazione.

Come spiegato da Xygalatas in un articolo sulla rivista Nautilus, il lavoro di molti filosofi, psicologi e neuroscienziati negli ultimi anni ha permesso di rivedere un modello «classico» di mente umana a lungo dominante, secondo cui i nostri processi cognitivi sarebbero simili a quelli di un computer che riceve input dall’ambiente e reagisce producendo determinate risposte. Sono ormai sempre più numerose le prove che il funzionamento del nostro cervello sia più sofisticato di così.
Più che essere un dispositivo che elabora dati, scrive Xygalatas, la mente è un «dispositivo predittivo», che «lavora attivamente per fare inferenze» riempiendo gli spazi vuoti e quindi prevedendo quali tipi di stimoli è più probabile incontrare in una determinata situazione. E lo fa sulla base di informazioni ricavate non soltanto dagli stimoli esterni presenti ma anche da esperienze precedenti, influenzate a loro volta da altre conoscenze e dalle nostre particolari forme di interazione con le altre persone.
Proprio per come siamo fatti, in altre parole, tendiamo a cercare schemi e regolarità statistiche ovunque intorno a noi. E di conseguenza, scrive Xygalatas, il nostro cervello diventa notevolmente più efficiente se può contare su conoscenze pregresse, senza bisogno di imparare di nuovo tutto da capo. Un effetto di questa particolare «architettura cognitiva» è che sperimentiamo ansia quando il potenziale predittivo è limitato da un elevato livello di incertezza.
«I modelli di azione ripetitiva insiti nel rituale funzionano come gadget cognitivi che ci aiutano a far fronte allo stress», conclude Xygalatas. E sul piano collettivo diventano parte delle nostre culture e di tutte le società umane in modo da permettere agli individui di capitalizzare il loro potenziale.

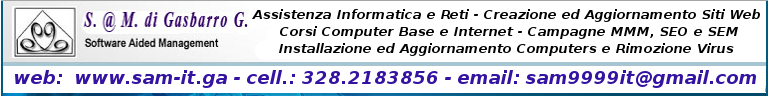


Lascia un commento